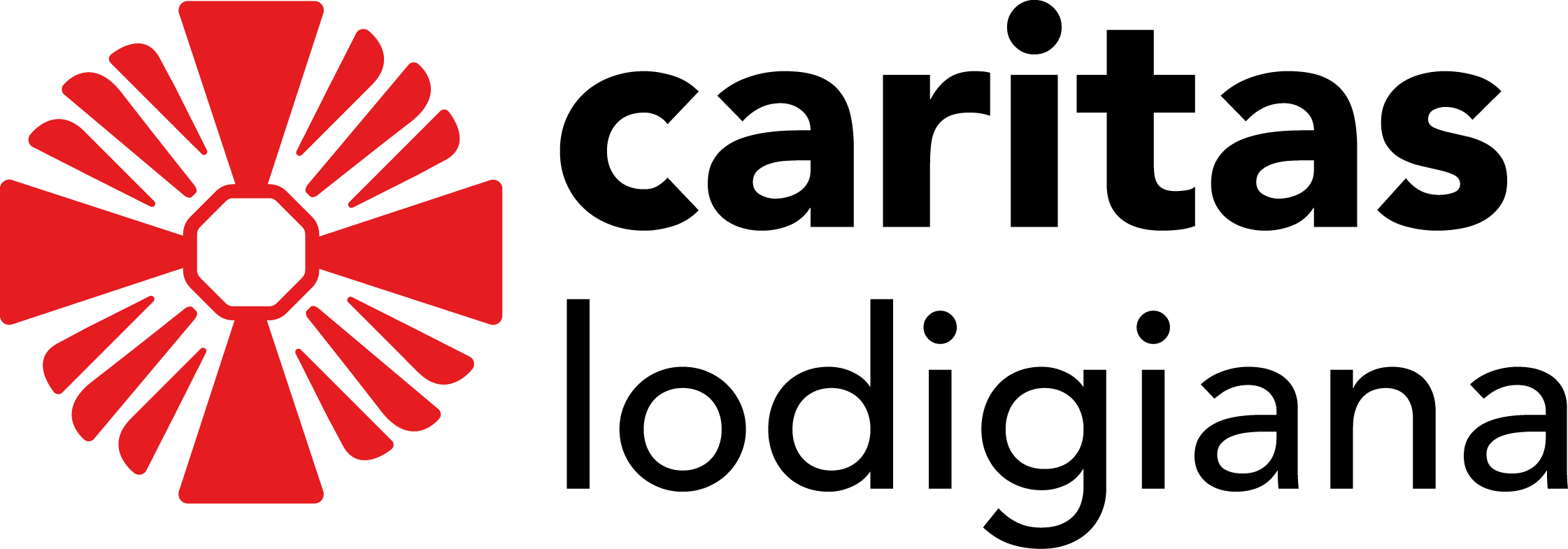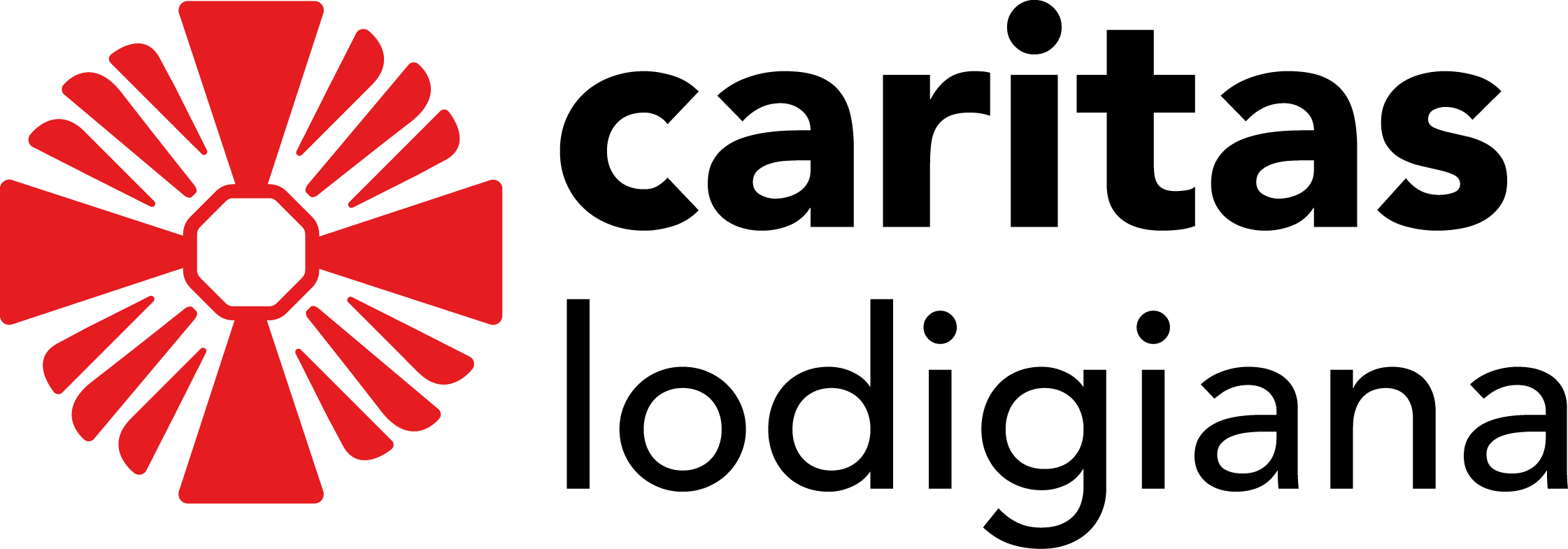Capitolo 13: Preghiera di sogno
- 27 Novembre 2023

Oggi il sole è caldo e vibra la vita macchiata d’inchiostro, i giorni, il tempo che passa e non torna più. Ci si riconosce figli indelebili di una realtà sola, fragile, insicura, anelli di vetro sulla catena degli anni. In continua tensione, attraversati dall’anima, pronti a cadere. Anche questa mattina è tempo di Mensa, ricevo una telefonata: Mara, la responsabile del turno del lunedì non può venire per un imprevisto, per cui m’incammino verso il solito portone. Anzi, verso la panchina, dove ci sono già Jimmy e Mario seduti sotto il sole cocente che, non risparmia nemmeno quelli che aspettano la corriera in silenzio. “dai andiamo di là” mi dice Jimmy dopo qualche minuto, mentre ci alziamo e attraversiamo la strada in cerca dell’ombra. “che mondo” continua “tutti fanno quello che vogliono ma nessuno che abbia un po’ di rispetto”. Quello ci vuole sempre, ma è tardi e il giorno consuma la vita. Sono cose che si sentono dentro, emozioni che si devono avere nel cuore.
Non c’è bisogno di nient’altro, di nessun’altra strada. Lo vedo arrivare da lontano, Ramadan, un amico guineano che si ferma a salutarmi. Mario, con la sua espressione stupita, si guarda un po’ intorno e poi gli rivolge la parola: “senti, mi devi dire perché quelli di colore come te..” Ramadan lo interrompe subito offeso e gli risponde in maniera brusca “Di colore? Quello non si dice, non è bello. Di colore sarai tu”. “Perché come devo chiamarti?” afferma Mario che non si rende conto che il ragazzo ci sia rimasto male. “Va beh – conclude Ramadan – non voglio neanche stare in questi discorsi” saluta e se ne va, con passo veloce, sulla strada per raggiungere Via Lodino. Restiamo un po’ in silenzio, non so cosa dire, ma probabilmente l’attesa raccoglie in se stessa la profondità necessaria per guardare la vita in modo nuovo. “Ho detto qualcosa di male? Forse lui si è offeso, ma non era mia intenzione”. “Fanno semper quello che vogliono loro, gli dai una mano si prendono tutto il braccio – va avanti Jimmy – se io fossi stato il capo qui, li avrei mandati tutti via subito”. “Perché non possono stare al loro paese? Non sono capaci?” conclude Mario. Non è proprio così, ho già cercato di spiegarglielo qualche volta, ma è complesso per chi ha visto cambiare il mondo così tanto rapidamente, riuscire a darsi qualche risposta. Soprattutto se si è in una situazione di difficoltà. In Sociologia si chiama Deprivazione Relativa, la paura che gli immigrati abbiano più di noi, vengano aiutati maggiormente, si ritrovino in una condizione migliore grazie a sussidi statali che invece agli italiani non vengono dati. Una falsa supposizione che anima in maniera più considerevole quelli che vivono la strada, che si abbandonano alla fragilità. Ci dirigiamo insieme verso la Mensa, il portone è chiuso, Stefano deve ancora arrivare. Jimmy non ci crede, prova invano a sbattere la porta di legno che però non risponde alle lamentele, così si sdraia sul marciapiede in attesa che arrivi qualcuno ad aprire. Il servizio trascorre tranquillamente senza problemi, io mi chiudo nel cucinotto e lavo, anche oggi. Intanto cerco di ascoltare le voci, le conversazioni degli ospiti.
Sono suoni lontani che animano il mio passare i piatti uno dopo l’altro. Il pomeriggio è alle porte e la stanchezza si fa sentire, il caldo è così forte che toglie ogni energia. Decido di fare una passeggiata, devo trascorrere il pomeriggio in qualche modo, prima di tornare alla Mensa per il turno serale. Leggere ho letto e non posso neanche andare alla Libreria Sommaruga per ricaricare le batterie, perché è chiusa, così mi dirigo verso Via Cesare Battisti e passo davanti alla sala Snai per vedere se incontro qualcuno.
Seduto lì fuori c’è Amidou con un bellissimo vestito islamico, a quadretti blu e grigio. Mi sorride “Ciao Ermano” Poi, mi chiede “ma che festa c’è qui domani che oggi è tutto chiuso?”. “È il giorno di Maria, la sua ascesa al cielo”. “Ah.. – Amidou ride e appoggia divertito la testa sulla mia spalla – però non è come il Corano lì sì che è proclamata vera Maria. Ma sai ognuno ha la sua mentalità”. Ancora “l’unica cosa che mi dispiace è che sia chiuso il centro diurno, così non abbiamo potuto fare colazione e stiamo fuori tutto il giorno, fino all’ora in cui possiamo andare a dormire”. “Quindi niente colazione oggi?” gli chiedo. “Si, però io l’ho fatta lo stesso, sono andato a prendermi un kebab”. Io, probabilmente, non lo avrei ancora digerito adesso il kebab, con la cipolla cruda e il peperoncino alle otto del mattino, ma ci sono profumi, sapori, idee che arrivano da lontano e necessitano di essere alimentate, o per lo meno ascoltate. Ricordo ancora il mio incontro con Chris Obehi un cantante nigeriano che avevamo invitato alla presentazione del libro scritto insieme al SAI ex Sprar di Lodi, per celebrare i vent’anni del servizio in città, insieme ai trenta dalla fondazione dell’associazione Progetto Insieme. Un ragazzo umile, vero, che mi è rimasto ancora nel cuore.
Solo con la voce profonda e una chitarra per ricordare il viaggio verso l’Italia, l’Africa terra del pane e la vita che risorge e si costruisce. Alto, capelli neri e un grande sorriso. La presentazione iniziava con una lettura di alcuni passaggi del volume. Mentre ero sul piccolo palco di legno in attesa di iniziare, ho guardato nel camerino e ho visto il cantante addentare un succulento kebab, magari era una sua tecnica per stimolare le corde vocali. Ma, ho ancora impresso nella mente questo ricordo che custodisco, in modo prezioso. Amidou mi guarda e con gli occhi neri, vivi, mi stringe la mano in segno di saluto. Proseguo sulla strada e scivolo tra le vie della città, fino ad arrivare in Via Vecchio Bersaglio, voglio camminare lungo il fiume. Così circondo l’intera area del Capanno e la strada mi porta a passare sotto il ponte Napoleone Bonaparte e a continuare verso quello che doveva essere il Bar del Paesaggio, ma che ora è solo una vecchia catapecchia di legno marcio. Mentre cammino qualcuno da dietro grida il mio nome, mi volto, è Kande un amico senegalese conosciuto in Mensa che sfreccia sulla sua bicicletta, proseguiamo insieme “Grande Ermanno, allora come stai?”. Sta ascoltando alcuni messaggi sul telefonino ma sembra essere poco interessato “notizie dal Senegal?” gli chiedo incuriosito. “Sono i miei cugini, che vogliono che compri i telefoni a tutti, ma come faccio io? Credono che vivere in Italia sia facile, che una volta arrivato qui sia a posto, ma non è così, come si fa a spiegarglielo?”. È vero, non è così, soprattutto perché tanti vengono con la speranza di trovare chissà cosa e poi alla fine trovano la panchina del parco, le coperte del dormitorio e un pasto caldo alla Mensa del pane spezzato. “Ci sono state tante persone, come Gheddafi – continua – che in Africa avrebbero potuto cambiare le cose e per questo le hanno uccise. Anche le rivolte che ci sono adesso derivano dal fatto che noi africani ci siamo stufati di questi governi corrotti filo occidentali, che da secoli sfruttano i nostri territori. Noi abbiamo tutto, ma siamo poveri”. Vorrei che anche Mario e Jimmy potessero ascoltare, ma non è il caso, ci sono i fili della luce e i morti che aspettano in volo, le strade del cielo più vero. Poi si gira verso di me e sorride, gli occhi grandi e la barba che circonda il viso, sulla maglietta nera il disegno di due tigri che ruggiscono. Tutti noi avremo bisogno di ruggire di meraviglia, parole nuove. Ogni volta che sorride il suo viso si apre e i segni della pelle si fanno più spessi e profondi, sulle guance, vicino agli occhi e lo tratteggiano di luce. Percorriamo la stradina nascosta tra gli alberi che porta al ponte della tangenziale, abbracciato dal fiume Adda, casa di tanti, intreccio di profumi e ricordi. Luogo di tempo, dove le vite si consumano. “Andiamo” mi dice. Saliamo e arriviamo direttamente a Casa Bianco, non si suona neanche il campanello per entrare, non ci sono cancelli. La lunga parete è coperta di scritte colorate, di graffiti, disegni che sono lì da anni. Passo dopo passo mi muovo in quello che sembra essere un mondo completamente diverso, ma che è a due passi dal centro storico, dalle case sicure, dai negozi di lusso. Biciclette ammassate, cartoni, sacchi a pelo, tende, brandine, pentole sporche, bicchieri e cassette piene di lattine di birra ormai consumate.
Passo dopo passo, letto dopo letto incontro qualche viso, lo saluto e continuo, finché raggiungiamo la loro zona. “Ecco – mi dice – questo è il letto di Diamanka, siediti pure che adesso arriva”. La vista è meravigliosa, non c’è niente da dire. L’Adda che si muove senza fine nel suo bacino di terra tra le fronde verdi degli alberi d’estate e il cielo limpido all’orizzonte. Ma, quello che si vive lì a Casa Bianco è il senso del non ritorno, la vita nella sua solitudine. Nessuno dovrebbe essere costretto a vivere così, a dimenticare se stesso. Dov’è la dignità, quella che avremmo dovuto costruire sulle ceneri della dittatura in quella forma di governo chiamata democrazia in cui tutti avrebbero dovuto avere gli stessi diritti e le stesse opportunità? Come possiamo andare avanti a consumare, a vivere nella ricchezza mentre c’è chi non ha niente? Non riesco a capire e porto le mani alla testa, sfregandomi gli occhi. È tutto vero, purtroppo. È il mondo che abbiamo creato. Vicino al materasso di gomma, ci sono i sacchetti della spesa in cui conserva qualche vestito e un po’ di cibo di scorta, biscotti, delle bustine di tè e del latte in polvere. La dispensa insomma. Poi qualche sedia di legno e la zona cucina, dove una pentola sul fuoco sta bollendo. Diamanka arriva con una tanica di plastica piena d’acqua. “Ecco Ermanno, questa è Casa Bianco – dice orgoglioso mentre si sdraia sul materasso sorretto in modo fragile dalla struttura in ferro – viviamo qui”.
Questo l’avevo capito purtroppo anche se ancora non volevo crederci. Ogni macchina che passa sopra di noi il ponte si muove e il rumore si diffonde tutt’intorno, piano piano mi abituo a questo movimento quasi consolatorio, che ci fa guardare la vita da una prospettiva diversa, quella di chi non ha niente e ha bisogno di condividere anche il poco che possiede. Ai fornelli c’è Sarr, un altro ragazzo conosciuto alla Mensa. Hanno fatto un falò e sopra sta cuocendo del riso. Il fumo si diffonde nello spazio circostante e si fa fatica a respirare, mentre le lacrime di cenere si alzano in volo. “Cos’è?” gli chiedo. “Ceebu Jen, anche se manca il pesce dentro e la verdura”. Meglio così, penso tra me e me. È un piatto tipico della cucina senegalese e vederlo preparato in questo modo, mi rende ancora più insicuro e trascina nel cuore la domanda radicale, concreta e necessaria del nostro essere e vederci legati agli altri. Le mosche si avvicinano una dopo l’altra, mentre il risotto è pronto e si condivide. Poi arriva il tempo del bagno. Diamanka e il suo amico approfittano del caldo per evitare la doccia del dormitorio in Via Defendente.
Scendiamo e ci dirigiamo ai piedi dell’Adda. Si tolgono le scarpe e si buttano nel fiume, spruzzando l’acqua e nuotando. Colgono l’occasione per lavarsi con il sapone e per farlo anche con i vestiti che poi stendono, una volta risaliti, a penzoloni nel vuoto. È come se fossero una grande famiglia, si mette in comune, si ricerca quello che non si ha, si guardano le cose dalla stessa prospettiva. Poi saliamo nuovamente in casa, è ora di giocare. Tirano fuori da una cesta in mezzo ad alcuni asciugamani un pezzo di cartone con disegnati sopra i quadretti neri della dama.
Diamanka prende una scatola di latta e rovescia alcuni tappi di plastica bianchi e rosa: sono le pedine. Così inizia la sfida e ridono, mentre si vince e si perde. Un po’ come nella vita, fino ad arrivare a quel giorno in cui solo al Signore dei Mondi resterà la voce per dire quello che siamo, per raccoglierci nelle braccia del giardino del paradiso, là dove scorrono i ruscelli e i prati in fiore vibrano di luce. Dove non esistono i buoni e i cattivi, i giusti e gli sbagliati, ma solo gli esseri umani. Le mani si muovono rapidamente, come se fossero figli di un incantesimo e di una speranza libera. Si prendono in giro “Straniero, hai perso!”, Boubacar ride e poi canta la musica che proviene dal telefonino e si diffonde nello spazio circostante “andale, andale, portami giù dove non si tocca…”. Gli piace, io cerco di sopportare quello che per me è solo rumore e vorrei intonare qualche verso di Guccini, chissà magari imparano qualcosa di più profondo, penso. Ma non è il caso. Mi stupisco però che non ascoltino le voci della loro terra, Youssou N’Dour, Ismael Lo per esempio, forse ci sono solo altri momenti, non quello del gioco, o probabilmente ci sono i ricordi che non fanno sempre bene. Bisogna evitare di sprofondarci dentro, altrimenti è tutto più difficile, più solo. Non è questa la vita che dovevamo costruire, una volta partiti, non è questo il sogno della Fede, della condivisione, dell’accoglienza.
Non c’è più niente, ma nella povertà rimane la dignità della persona e la relazione. Questo non si dimentica. Non se ne vanno i sogni, fragili, in bilico, trascinati dal vento, spinti per caso in un pomeriggio come gli altri, nella casa del ponte, bianca e calda di sole. Alla sera c’è la Mensa, è tardi, il tempo è passato ed è ora di incamminarsi, così usciamo. Diamanka e i suoi amici non verranno questa sera, la pancia è già piena, non serve riempirsi di troppo. Ma io, anche se lavo i piatti, scambio qualche parola con Konateh e gli stringo la mano, bagnata di sapone e detersivo, non riesco a pensare ad altro. Nella testa le immagini, i profumi, i suoni, il rumore del fiume d’estate che stringe in un abbraccio profondo con l’anima. “questo lo avete fatto voi?” mi chiede Diamanka dopo aver fatto il bagno mentre appoggia le mani sulle ginocchia e guarda con la testa china sull’acqua trasparente i piccoli pesciolini che nuotano velocemente da una parte all’altra. “Come lo abbiamo fatto noi? – lo guardo stupito – l’Adda sfocia nel fiume più lungo d’Italia il Po”. “Come hai detto che si chiama: abba?” “Adda!”. “La prima volta che l’ho visto ho pensato fosse artificiale”. L’Adda? 313 km di acqua e di storia che attraversano anche le pagine di Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi E stando così fermo, sospeso il fruscìo dÈ piedi nel fogliame, tutto tacendo d’intorno a lui, cominciò a sentire un rumore, un mormorìo, un mormorìo d’acqua corrente. Sta in orecchi; n’è certo; esclama: – è l’Adda! – Il fiume che tutto ricorda, le barche, i sorrisi, i giorni della sete, che è letteratura, poesia, frammento di pagine bianche sulle parole di domani. Il mio sguardo scivola ancora in questi frammenti di vita che ormai sono solo ricordi, parole, volontà, che si stringono dove il giorno finisce e arriva la notte. Lì penso là i tanti, mentre si prepara la notte, forse si litiga, o forse no, ci si sistema sotto le lenzuola, per cercare di proteggersi dalle zanzare che mi dicono “d’estate sono moltissime”. E si ammira il fiume scorrere senza tregua, i prati verdi, le piante dell’estate, ci si ritrova circondati da quello che pensiamo essere il nostro tempo ma che dobbiamo ancora cercare. Ha ragione Giselle quando mi dice che nessuno dovrebbe vivere in queste condizioni, quando mi spiega che non è possibile continuare a stare qui con la stessa mentalità dell’Africa, bisogna sapersi adattare, pensare di dover stare bene e poi far stare bene ugualmente gli altri. Senza questo principio il ruolo di chi semina l’accoglienza è vano, senza questa consapevolezza non abbiamo neanche più la profondità radicale di poter dire di Esserci e di continuare a respirare. Così la Mensa con i suoi volti, gli sguardi, le profondità mi porta in Africa, mi conduce nei luoghi di tutto e di niente, dove anche i giorni si perdono nel buio e ci ricordiamo di quello che siamo, di quello che non abbiamo il coraggio di diventare, spinti dall’incertezza, eterni migranti dell’esistere. Una volta uscito dalla Mensa con la maglietta bagnata, ripenso alla giornata, i sandali con i piedi pesanti di sabbia, la voce dell’uomo che grida il mio nome, che cerca la strada di casa e scrivo, ancora. In continua ricerca, clandestino sulla terra del sale.
Non ci sono più i sogni bambini a giocare sull’erba del prato, la sabbia e il mare. Ma il fiume preghiera del sogno un bagno di tempo e sorriso il cibo sui piatti di vetro la musica dolce del ponte che nasce e risorge l’estate, profumo di grano. C’è il segreto nel letto di stracci, la voce che canta le storie del sole, coperte, lenzuola, vestiti puliti, sacchetti di tutto e di niente, armadi che hanno gli oggetti del cuore il fuoco che scalda la voce dell’uomo, profilo d’incenso che ride e che piange, che ama sulla sua bicicletta, incontro, promessa di fede Che non c’è più niente domani.
Ascolta l’episodio anche su Spotify
Comments
Condividi: