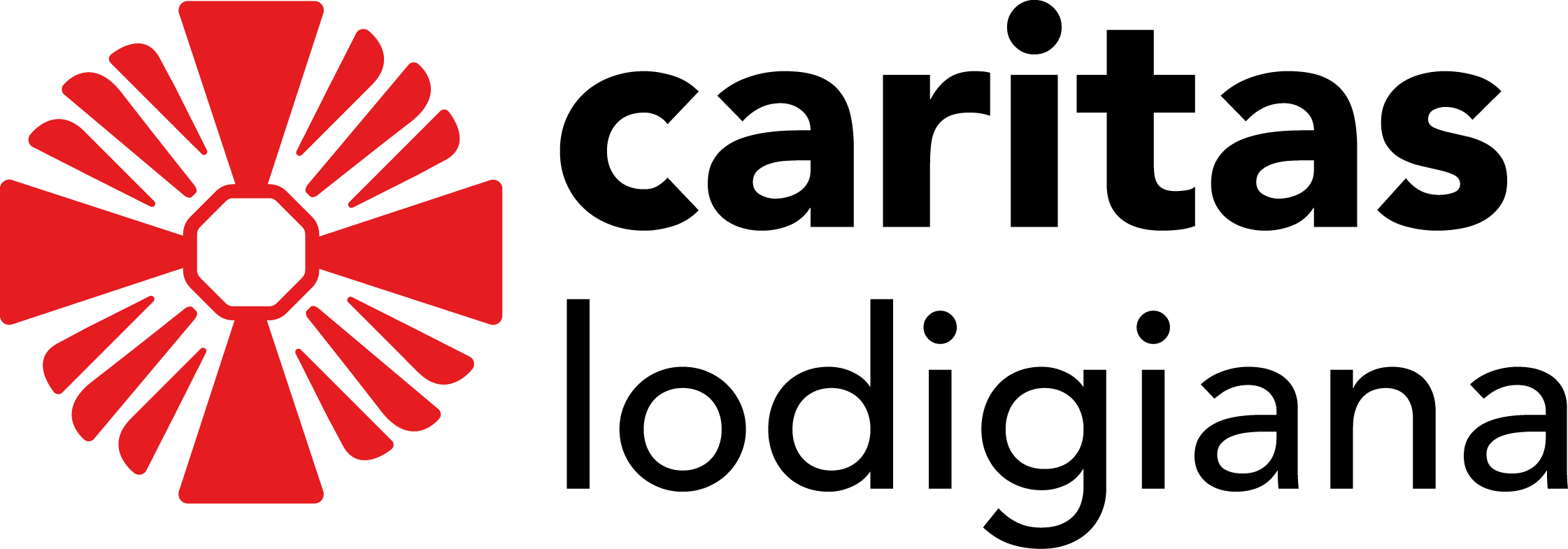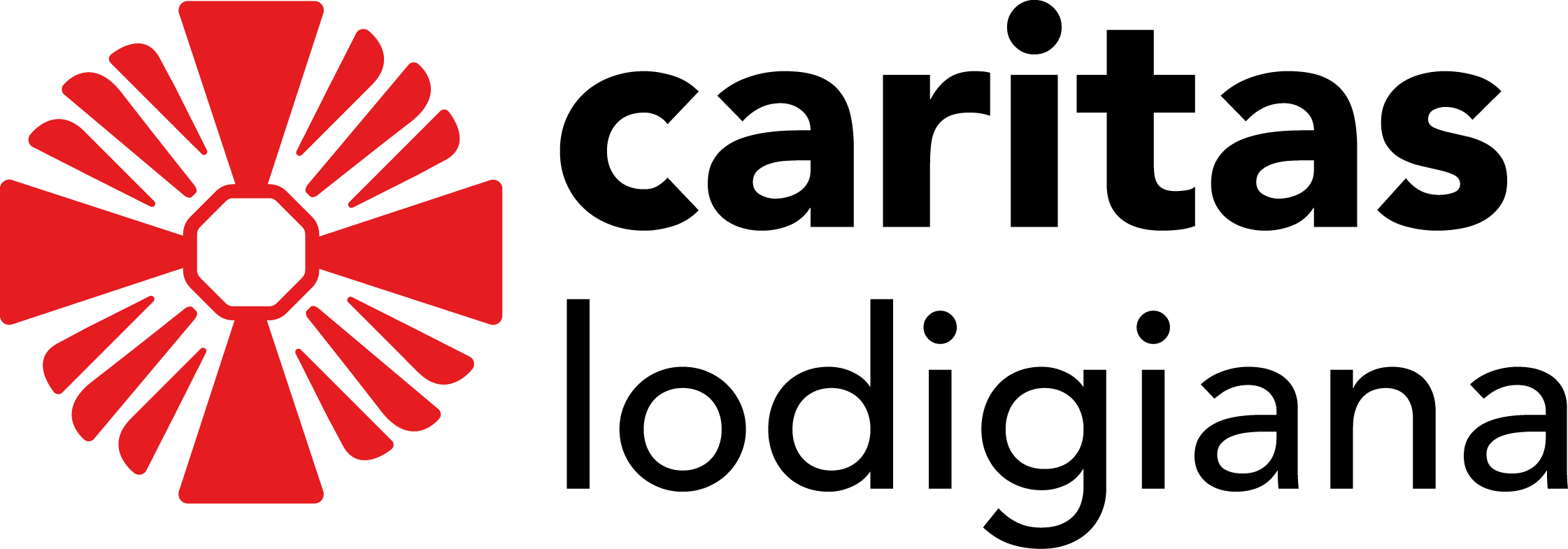Capitolo 9: Come gli altri
- 30 Ottobre 2023

Il cielo sopra la campagna lodigiana oggi promette pioggia, ma non si sente neanche il profumo, non la si riesce a respirare. A tratti il sole cerca di fare capolino dalle nuvole appese all’orizzonte. Io, invece, ho una terribile emicrania, mi capita qualche volta e ormai ho imparato a farci i conti e ad accettarla. Non posso fare niente: solo aspettare che passi e andare avanti, sopportando il dolore che rende difficile anche la relazione con gli altri, a tratti annebbia la vista e non permette di sorridere in modo vero. Percorro le strade di Lodi, umida, vera, con la Piazza e i sassi del fiume, le vie, le panchine lungo i giardini Barbarossa, che diventano la dimora di qualcuno che non sa dove passare la notte. Appesi ai rami dei cespugli intorno, una coperta e il sacco a pelo. Poi si scende per Via Lodino, tra i colori e i profumi d’Oriente, nella scoperta del Sacro che si unisce al profano, nell’incontro con la multiculturalità. C’è spazio per tutti: chi ha sete, chi cerca respiro, chi si perde nelle traiettorie dell’esistere. Poi piazza Barzaghi, crocevia di strade, abbraccia la chiesa neoromanica del Borgo, che si getta con le sue tre navate in mattoni e pietra, sul ponte dell’Adda che allunga la città in nuove prospettive. Camminare per Lodi, fermarsi a osservare i particolarismi artistici e architettonici, diventa messaggio radicale per costruire una nuova umanità, fatta di poco, di tutto e di niente, di necessità, di volontà, di sogno. Qualcuno mi chiede “ma non vai in vacanza?”
Andare in vacanza ci vuole qualche volta, ma quando rispondo che quest’anno non riuscirò ad andare, mi guardano sempre con un’espressione a metà tra la compassione e il finto dispiacere. Però non è un problema, rispondo, a Lodi si sta sempre bene, tutto l’anno. Non c’è bisogno di ricercare chissà cosa, di perdersi in chissà quale anfratto di tempo, quello che conta è saper cogliere le bellezze che la vita ci sa offrire dovunque siamo. Le cose positive e i dispiaceri, le difficoltà, le solitudini per cercare di ripartire nuovamente, di stringere tra le braccia il fiore della nuova umanità, del tempo che trascende il finito e si ritrova nella possibilità gnoseologica di viaggio e di sorriso. Arriverà il tramonto dell’Africa, terra del pane, ma intanto cerco di viverlo qui e di capirlo, di entrare a contatto, di condividere, di farmi strada, anche con difficoltà, nel sole che non ritorna. Questa mattina è giorno di Mensa. Sto aspettando davanti al portone che arrivi Pito per aprire.
La portineria del seminario ad agosto è chiusa e l’unica possibilità di entrare è questa. Non ci si può neanche sedere sulle solite panchine, perché sono in corso i lavori per rifare le pavimentazioni. Vedo arrivare Mario da lontano. “Non ci si può sedere oggi sulle panchine” “ah no? Io mi sono seduto lo stesso, un po’ di polvere, c’è quello con i capelli un po’ arruffati oggi?” “Chi? Pito?” gli chiedo incuriosito.. “Ah così si chiama…” Arriva neanche a farlo apposta, nel frattempo e Mario scherza con lui “mi sembravi un giovanotto da lontano” “e se vado ancora più lontano un bambino” dice lui ridendo, mentre fa girare le chiavi nella serratura. “vedi – continua Mario rivolgendosi a me – lui si è portato l’ombrello è stato previdente, io invece ce l’ho in macchina”. “Bravo… vai a prenderlo, che mentre siamo qui piove sicuramente”. gli risponde Pito “Poi quando inizia vado” “Così ti bagni tutto”. Non serve l’ombrello, alla fine tanta paura per nulla, non piove nemmeno una goccia e alla mensa si serve pasta con il tonno, verdure e formaggio. Tipico pranzo d’estate, come la caprese con il purè di patate del giorno prima. “Io non ho mai visto nessuno mangiare il purè insieme alla mozzarella e al pomodoro” esclama Giselle stanca e divertita. Passa come le altre questa mattinata alla Mensa, scambio qualche parola con Konateh e poi mi occupo di riordinare le stoviglie e di preparare la macedonia per la sera. Tutto tranquillo, tutto fin troppo strano, pronto ad avvolgersi di quelle piccole sicurezze di cui abbiamo bisogno. La testa non smette di far male, penso di mangiare qualcosa, magari passa, così attacco qualche acino d’uva ma non serve, anzi il dolore sembra raddoppiare. Mando giù un pezzo di pane con un po’ di formaggio, ma niente. Devo accontentarmi e aspettare: oggi va così. Usciamo dalla mensa e sui davanzali della finestra troviamo come di consueto le bucce di banana “se scopro chi è gli spezzo le gambine” afferma Luigi con il suo solito sarcasmo. Ognuno ha le proprie dimensioni, modo di essere, di ricercare ed entrare in contatto con gli altri.
Mentre cammino verso casa incontro Mohammed seduto su una panchina ai giardini Barbarossa e inizia a parlare, come fa lui, con gli occhi un po’ vuoti e la voce che si perde nel tempo e nello spazio di un non luogo. “Cosa stai facendo – mi chiede – studiando?” Gli faccio vedere il mio quaderno nero, sfoglia le pagine una dopo l’altra dove ci sono le poesie, le emozioni, le immagini, le parole. Gliene leggo due e lui mi dice “potresti fare un film”. Un film? Con le poesie, ma è meglio non chiedersi perché, non c’è niente da capire, solo da vivere, da lasciare correre. “Ho scritto un libro di poesie Africa” “E a quanto lo hai venduto” “quindici euro”. Allora Mohammed inizia a prendere in mano la calcolatrice sul telefonino e a fare i conti per vedere quanto avrei potuto guadagnare se avessi venduto tutte le copie. “Ma non lo so quante copie ho fatto stampare – continuo – sai di quello se ne occupa l’editore”. Poi inizia a sfogliare le foto sul telefono, c’è lui sul treno a Pavia, con i suoi amici in Libia quando era piccolo, il suo amico d’infanzia con la moglie e il fratello tornato in Gambia.
Adesso tutto è diverso, c’è lui seduto su una panchina a spezzare il tempo, i ricordi che brillano come luci di nostalgia e che arrivano dritte al cuore. C’è il sale e la gioia di volersi ancora emozionare e sognare, come quando si è bambini. “guarda i miei capelli – mi dice, mentre si tocca i dread che cadono a malapena sulla fronte – sono ancora corti, però stanno crescendo troppo, vorrei farli tutti neri”. C’è il desiderio di poter pensare ai capelli, di condividere il poco che ci fa sentire vivi, di emozionarsi, così come quando vede arrivare un cane che il proprietario ha lasciato senza guinzaglio e vuole in tutti i modi accarezzare. Non ci riesce, perché questo corre dal padrone, ma lo guarda divertito. Mentre si passa le mani sul viso. Troppo fragili, caduti sui ponti del cielo. La Mensa si raccoglie nelle necessità e nei viaggi verso il futuro, nella fragilità di poter dare qualcosa in più, di potersi ritrovare in volo sul cielo, tra i miraggi del tempo perduto, della vita che continua a essere respiro per chi affronta questo mistero inspiegabile. Così è subito sera ed è ora di iniziare il turno. Cerco di passare più tempo possibile lì per coglierne il sapore, per cercare di raccontare ciò che è denso di vita, ciò che si nasconde al freddo della mente. Kabu, apre ai volontari che entrano uno dopo l’altro. Una signora si avvicina a lui e gli chiede divertita “ma hai freddo?” Lo vede vestito con il cappello e la camicia di flanella e si preoccupa. Così come tutti quelli che glielo avranno chiesto, chissà quanti. Penso a Cheick e al modo di essere se stesso, nonostante tutto. Dovrebbe essere la regola di ognuno di noi, in un mondo in cui l’omologazione sembra far sentire tutti più sicuri, in realtà solo figli del consumo e della fretta. Così replica, con il sorriso sul volto “Sa signora, qui dentro con l’aria condizionata fa un po’ freschino, troppo per me”. Lei allora va a mettersi il grembiule, con un’espressione un po’ confusa. Sembra non aver capito, che in un certo senso Diack le abbia detto gentilmente “Qualche volta è meglio non fare domande simili”. Abbiamo iniziato prima del solito a servire. Questa sera pasta con i broccoli, bastoncini di pesce e insalata. Jimmy protesta come al solito. “Non è buona?” gli chiedo “Non è fatta come cazzo dico io”. Piano piano arrivano anche gli ospiti, Diamanka si siede vicino a Jimmy e inizia a stuzzicarlo.
Alcuni africani si divertono a farlo arrabbiare, perché conoscono il suo carattere, il suo modo di essere un po’ particolare. “Stai zitto e mangia!” urla Jimmy. A un certo punto l’attenzione di tutti cade sull’ultimo tavolo in fondo a destra dov’è seduto Mujeeb, con la forchetta e il coltello picchia ripetutamente sulla macedonia, facendo ruotare pericolosamente il bicchiere di vetro sul tavolo. Sempre con più forza e aggressività, mentre gocce di frutta fresca si disperdono tutto intorno. Anche gli altri ospiti si fermano e il silenzio cala nella sala, stanno tutti osservando quell’attimo folle di agitazione che spaventa. Konateh che è seduto allo stesso tavolo, mi guarda impaurito e cerco da lontano di rassicurarlo. Poi a un tratto finisce e immerge il cucchiaio nella poltiglia di frutta e lo porta alla bocca. Scampato il pericolo di un altro bicchiere rotto, la cena può riprendere.
Quando si alza e se ne va, devo passare lo straccio sul mare d’acqua che ha creato sul tavolo per far sì che anche altri si possano sedere. Jimmy questa sera è agitato e quando Diamanka e Kande, dopo aver scherzato un po’ con quello strano vecchietto dai capelli bianchi e senza denti, si alzano per andare via, lui li insegue, alzando la gamba per prenderli a calci nel sedere, ma non ci riesce, mentre questi escono correndo e ridendo di gusto. Sono le vive emozioni di chi ha bisogno di divertirsi un po’. “Se io fossi stato il capo qui gheran no tuti questi a rumper le bale” dice mentre finisce di masticare il bastoncino di pesce. Lo guardo un po’ divertito, mentre si riprende a lavorare. La sera cala su Lodi e il mio mal di testa non accenna a lasciarmi un po’ di tregua. Anzi comincio a pensare che questa notte non prenderò sonno. Il cielo si raccoglie in un vento freddo e nei nuvoloni scuri che si mischiano al rosa del tramonto in un dipinto quasi espressionista. Dai trenta gradi del giorno prima, adesso ce ne sono venti e Kabu ha fatto bene a mettersi la camicia di flanella, mentre si infila il suo zainetto sulle spalle e mi saluta percorrendo la strada verso il dormitorio. Oggi non posso accompagnarlo, ho paura di prendere la pioggia e ho voglia di mettere la parola fine a questa giornata, così lunga e complicata, che con indosso il camicione africano che mi ha regalato Giselle è stata però più protetta e rassicurante, nonostante tutto. Tornano alla mente le parole scambiate insieme a un’amica, Giu Ricc, proprietaria dell’agenzia immobiliare Gabetti di Lodi, questo pomeriggio, in attesa di andare alla Mensa, davanti a uno dei nostri tanti caffè decaffeinati. “Dobbiamo mantenere la nostra personalità, non lasciarci mai assorbire dalla massa, dal desiderio di essere come tutti, di fare certe cose solo perché le fanno gli altri.” “Il nostro modo di vivere – continua Giu – ormai solo virtuale, per me che sono figlia degli anni ‘70 è così difficile da capire”. “Siamo caduti in modo profondo nel mondo delle macchine che non riusciamo più a distinguere nemmeno la persona” le faccio eco io. Ma dov’è finito l’uomo? La sua forza inequivocabile di sognare, di rendersi partecipe delle identità condivise e delle possibilità. Quali tempi, quali spazi di sogno.
Così ripenso ai volti e alle immagini della Mensa, a quelli che fanno capolino ogni giorno dal portone, che donano una stretta di mano, un abbraccio che vale una vita, che si riconosce responsabilità d’amicizia finita e mutabile, che ci fa scoprire esseri umani, ogni volta, con il sapere disinteressato dello sguardo.
Riconosco Amidou, Kande, Konateh, Diamanka che sfreccia alla mattina sulla sua bicicletta, in Via Secondo Cremonesi e grida il mio nome al vento, dopo aver passato l’ennesima notte a Casa Bianco, tra il sogno del non ritorno e il pane spezzato. O anche Mamadou che dice sottovoce
“mi dai un piatto di pasta in più, perché ho tanto fame”.
Mentre si stringe nel suo cappellino blu e nel sorriso di un ragazzo che ha solo ventuno anni e che vive lontano da casa, appeso su quello che non avrebbe voluto. Poi non ne ha bisogno di un piatto in più, non si può, si riempie il bicchiere di macedonia ed è comunque contento. Sono gli attimi della Mensa, dove essere come gli altri, vivi nella disperazione kierkegaardiana è quasi impossibile. Dove si trascorre il silenzio e la speranza, la ricerca di Dio e la fede che è grande, viva e profonda, che ci anima il cuore, anche di chi vive nel relativismo, nella certezza di essere l’assoluto. Non siamo che la nostalgia dell’anima, l’idea che ritorna in sé dalla sua alterità, il principio primo del pensiero. Il messaggio dell’essere come si è, percorrendo la strada dell’esistere, nel dialogo con la profondità dell’esistenza, senza dimenticare l’essenza del cammino e dell’anima, reale e profondamente legata al cielo nelle vie di passaggio più vere. Così come Francesco Guccini e la sua canzone di notte, per le stelle e la luna, per gli ultimi e i soli, per chi ancora cerca il proprio posto nel mondo, eterno migrante.
Scusate, non mi lego a questa schiera, morrò pecora nera.
Ascolta l’episodio anche su Spotify
Comments
Condividi: