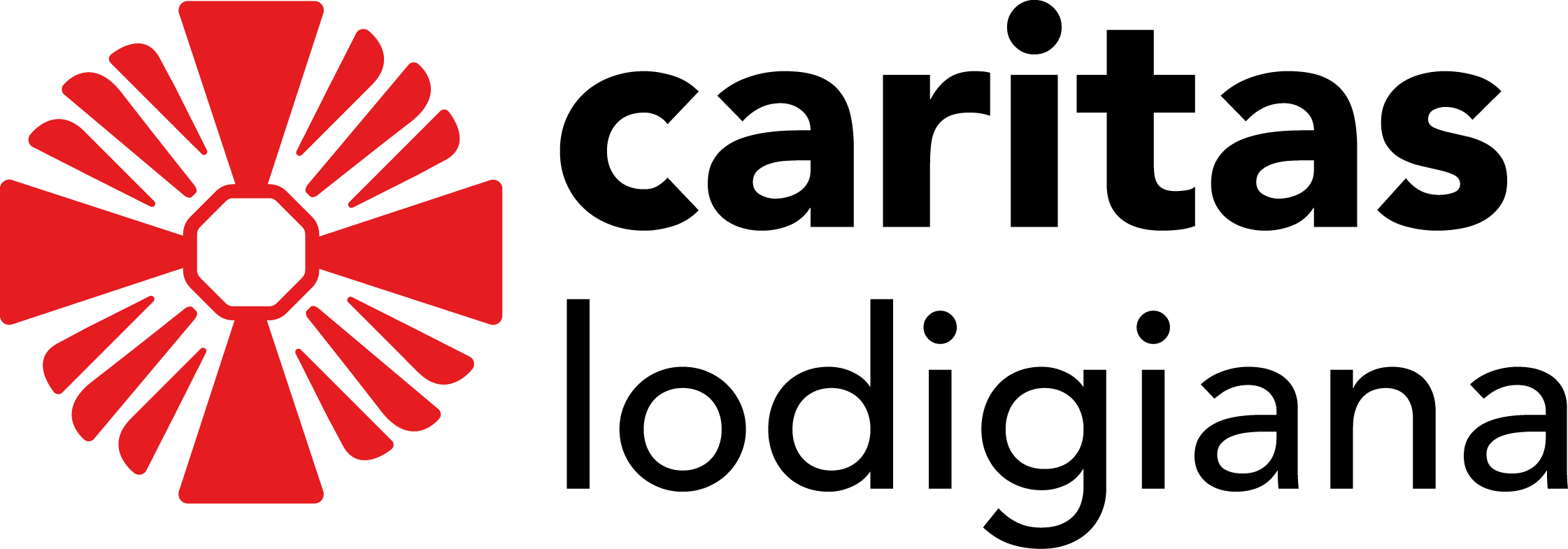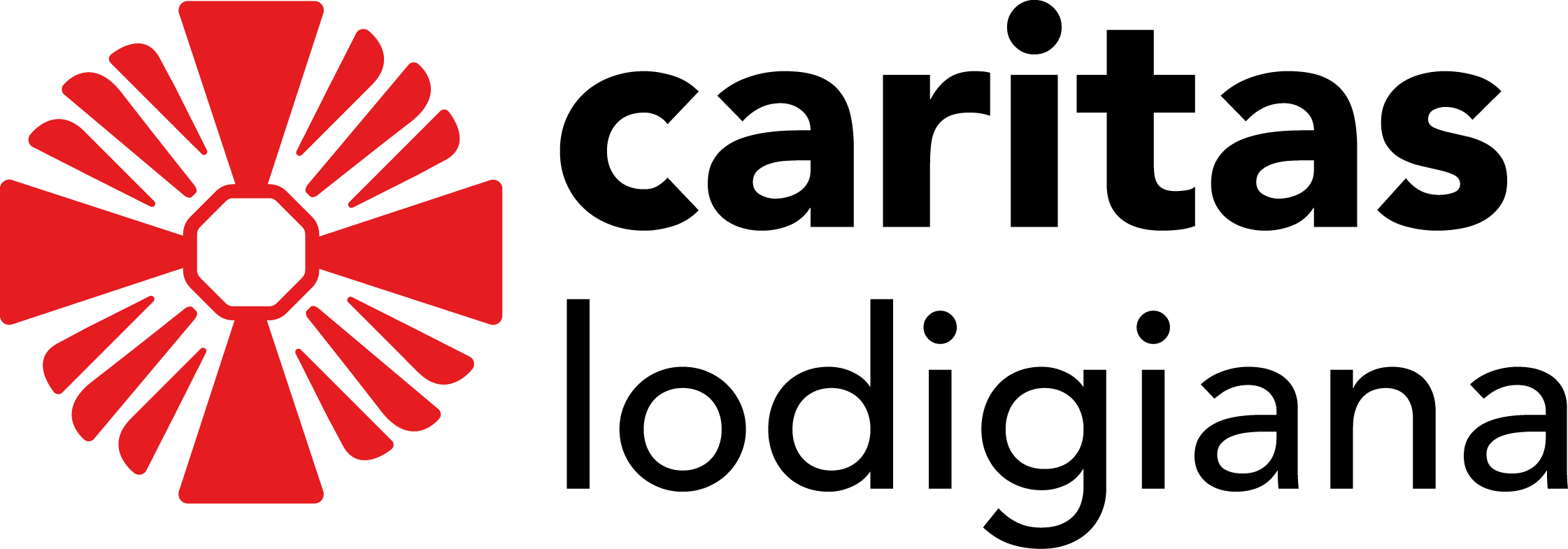Capitolo 6: Confessioni
- 9 Ottobre 2023

Fare volontariato alla Mensa era sempre stato un grande desiderio, conservato, protetto negli angoli del cuore. Cullato nell’attesa che rende le cose profonde, che forse vale ancora di più della stessa emozione, come se fosse Giacomo Leopardi e quel sabato che si ritrova vero e vivo nella domenica come nostalgia del giorno dopo. Ma qui c’è il vivere ogni cosa con l’anima e il senso, con quello che può dare. Sia l’attesa, sia il ritorno, sia quello che cerchiamo. Alla domanda fatidica che mi veniva posta: “Quale sarà la prima cosa che farai dopo aver compiuto diciotto anni?” rispondevo “finalmente potrò fare il volontario alla Mensa Diocesana”. Senza sbandierarlo ai quattro venti, senza la necessità di esibirlo, una volta acquisito. Ricordo ancora la prima volta che sono entrato dal portone di legno insieme a Giselle un martedì sera d’estate. Il caldo e il sole senza rimedio. Mi guardavo intorno cercando risposte in quei visi che entravano uno dopo l’altro. Scuri, tristi, felicemente adeguati al vivere e all’incontro. Poi, settimana dopo settimana li ho conosciuti, ma non ho mai smesso di imparare da loro, di ricercare i comportamenti più adeguati, di migliorare la crescita e la condivisione dell’identità confusa di mistero. Alcuni se ne sono andati e un giorno usciti da quel portone non li ho più rivisti “alla fine del mese andrò in una comunità di recupero… eh il gioco d’azzardo”.
Così è stato anche per difficoltà che, all’inizio, concepivo in modo un po’ inesperto e fragile. Perché questa vita e questo tempo? Ho imparato a cercarlo in un luogo che è diventato una seconda casa, un centro d’ascolto, un porto sicuro, dove ritrovare se si vuole anche il sapere disinteressato della condivisione. Così come Vittorio Alfieri in quel suo Tacito orror di solitaria selva:
“Tacito orror di solitaria selva, di sì dolce tristezza il cor mi bea, che in essa al par di me non si ricrea, tra’ figli suoi nessun orrida belva”.
È conoscere ristoro nel posto, per antonomasia meno ospitale, meno figlio di rifugio, vuol dire riconoscersi per il Poeta lontano dalle masse, dalla loro onnipotenza, dal qualunquismo del senso comune. Ricercare un fine più grande “Non ch’io gli uomini abborra e, che in me stesso mente non vegga, e più che in altri assai; nè ch’io mi creda al buon sentier più appresso: ma non mi piacque il vil mio secol mai”. Quell’epoca coraggiosa non piace ad Alfieri, non ritrova il senso, la correttezza, la profondità, quel verde vigor rude che per Gabriele D’annunzio era invece la necessità più essenziale del panismo, del riconoscersi parte di quel tutto, con la pioggia e il pineto del tempo sul mare.
Come facciamo a stare accanto alla nostra identità, alle profondità, al fatto che prima o poi un giorno dovremo andare via, lasciare tutto, dimenticare? “Tutti dobbiamo morire” mi disse una volta Ramadan, amico guineano, mentre uscivamo dalla Mensa insieme. È vero, tutti dobbiamo morire e non possiamo spiegare questo senso così grande, questa impossibilità che ci attanaglia il cuore. Un giorno dobbiamo morire, ma ce ne sono altri 26000, per non nascondersi, altri 26000 per liberarsi e rivelarsi. Uno dopo l’altro. Seduto sulla solita panchina delle 18:20, insieme a Mario. Chiacchieriamo un po’. Arriva un signore egiziano che aspetta anche lui l’orario di ingresso. Capelli bianchi, a tratti grigi e un viso un po’ allungato con una voce che lo fa sembrare quasi del tutto italiano, forse più di me. Non fosse per il telefonino che è impostato con tutte le scritte in Arabo, ci si potrebbe confondere. Si siede vicino alla mia destra e mi ritrovo in mezzo a due fuochi che piano piano si accendono.
“Non è che ce l’avessi con te ieri quando abbiamo litigato – dice Mario – è che io sto già aspettando una casa”.
“Adesso basta Mario – grida l’altro, mentre i due visi si avvicinano sempre di più – ti ho già detto che per me è una storia chiusa, non discutiamo sempre delle stesse cose, oggi è un altro giorno”
Io, che mi trovo in mezzo alle grida, cerco di calmarli,
“è vero dai, adesso basta, nella vita certe volte serve anche arrabbiarsi, discutere, confrontarsi per poi ripartire nuovamente”.
“Sì, però se vogliamo fare le cose come si deve, altrimenti chiamiamole stronzate” conclude Mario.
I due si guardano ancora una volta, poi la tensione scende e anche il mio silenzioso battito del cuore, appeso sul filo, sulla panchina del ricordo. Ce ne sono alcune come luoghi di vita, che possono raccontare una storia, che segnano tratti di esistenza più vera, così come nel libro di Beppe Sebaste Panchine: come uscire dal mondo senza uscirne. Come facciamo a condividere il nostro tempo e lo spazio avvolto dal mistero e dal segreto inviolato della carne e della parola, dell’amicizia come parentesi concreta del cammino e della possibilità, del continuo ricercarsi attraverso le prospettive del crescere e del condividere? I giorni, vivi anche in questo aspettare, che si aprano le porte, sulla volontà della sete. Poi si parla nuovamente del cibo che viene servito, della sua qualità, di quello che pensano gli ospiti, ma soprattutto di quello che pretendono. Certe volte, troppo. Ma siamo fragili, sicuri e indifesi, vivi e addolorati, fermi e in continuo viaggio. Ossimori del nostro camminare. C’è tutta la vita nell’attesa, nel dolce sorriso di Konateh che mi saluta, nei piatti che bisogna lavare di corsa perché tanti sono senza e non possono mangiare. Tutto nella metafora di Lamine che apre il portafoglio e con gli occhi illuminati mi fa vedere che conserva il biglietto della Caritas con la mia immagine del Dona il tuo 5 x 1000.
Giornate e cambi di stagione, passaggi filosofici tra la terra e il mare, nella possibilità della Fede, come necessità. Non possiamo non ritrovarci in questo mistero, scrivere le parole e le pagine, ascoltare le storie che ci vengono donate mano nella mano. Spesso ci lamentiamo, contenti, insoddisfatti, nella vita così come nel nostro servizio Mensa. I piatti che sono troppo pochi, i bicchieri che si rompono continuamente, gli strofinacci che sempre i soliti si portano a casa da lavare. I luoghi della cucina dove bisognerebbe pulire con più attenzione. Ma è vero che per tutti, o almeno per chi vive questo servizio nel cuore, la Mensa rappresenta un luogo di rinascita, un crocevia di storie, di strade, di racconti, di possibilità, una realtà che aiuta a prendere una boccata di ossigeno davanti alla vita e alla società certe volte soffocante. Me lo confida anche Kabu, una sera, mentre cammino con lui verso Casa San Giuseppe
“Volontari bisogna esserlo anche nel cuore”.
Non come qualcuno che stava per iniziare a fare il volontario e una volta mi disse, con un’espressione alquanto superba “dai che andiamo lì, ci divertiamo, facciamo un po’ di cose e via!” Ci divertiamo, facciamo un po’ di cose e via? Non so che idea avesse in testa e se adesso la pensi ancora così. Ma credo che fare questo tipo di servizio sia qualcosa di profondo, come se si tracciasse un segno nell’anima, la voce più grande dell’esistenza, che supera l’atto volitivo nella ricerca più profonda e viva dell’Io. Non sempre ci si diverte, non è un parco giochi. Ma un luogo dove soprattutto alla sera, la fragilità si amplifica e il cielo si raccoglie nelle prospettive del vivere e del riconoscersi e il nostro essere si fa insicuro. Ho il ricordo ancora vivo di una sera d’inverno, come un’immagine che non si sbiadisce. Lo vedo arrivare, alto, con i suoi capelli lunghi marroni, la pancia rotonda e l’espressione di ghiaccio, fredda, vuota, fa fatica a tenersi in piedi, si trascina per la sala. La responsabile si siede un attimo con lui, cerca di parlarci. Poi lo aiutiamo con il vassoio e inizia a mangiare muovendo le mani a rallentatore, lentamente, come se stesse barcollando nel suo dolore, nel grido grande della fragilità e della disperazione. “Quando lavoravo in farmacia – mi sussurra Licia – veniva sempre da me a comprare le siringhe”. Non serve altro, non bisognerebbe aggiungere altra sofferenza a quella che vive ognuno nel proprio cuore, possiamo cercare di affrontarla in modi diversi, di riconoscersi parte integrante del tempo o di abbandonarci ad esso, facendo finta di niente. Che tanto in pochi ci vedono, che tanto il sole sorge e le nuvole si stagliano nel cielo come traiettorie invisibili di luce. O ancora, un martedì sera un volontario inizia a pulire i tavoli mentre in uno si sta ancora mangiando. Questi gli chiedono di smettere perché gli dà fastidio, chiaramente lui risponde: devo andare a casa anche io. Così uno dei ragazzi si alza e inizia a urlare, mentre la voce di Giselle che immediatamente interviene, cerca di superarlo. Poi si rivolge ai volontari con parole poco gentili, meglio non scriverle, ed esce dalla Mensa urlando. Ecco, dire: dai che ci divertiamo, facciamo un po’ di cose e via, ai miei occhi suona strano, confuso, protetto dal velo infantile del mistero. Senza giudizio, ma con la necessità di continuare a guardare le cose nella loro profondità.
Così come Emil Cioran, nel suo Breviario dei vinti che fa della filosofia il fine più grande della vicinanza con la sofferenza, con il dolore, la calma dei sensi, l’eterno ricercare dello spirito. Non riesco a riconciliarmi né con me stesso, né con altri, né con le cose. E neppure con Dio. Con lui in nessun modo. Rifugiarmi, come un adoratore stupido, nelle sue fredde braccia? Ma io non ho bisogno di un giaciglio buono per vecchie allo stremo. Mi riposo meglio sulle spine di questo mondo e quando mi irrito divento a mia volta una spina nel corpo del Creatore e delle sue creazioni Diventare una spina nel corpo del Creatore e delle sue creazioni, c’è il Demiurgo, Dio che per il filosofo rumeno serve a dare voce all’anima di tanti, al nostro sentire, alla relazione come sentimento più profondo della non ricerca, senza fine. Per giungere all’ultimo sorriso, la docile fibra dell’universo ungarettiana, il panismo dannunziano, la sinfonia nascosta del nostro cuore. Essere l’anima del vuoto e il cuore del niente, scrive, tutto e niente nella schiuma dell’istante. L’anima e il vuoto, trasfigurati nella nostra esistenza ultima, nel cuore della vita. Come se fosse l’ambivalenza che si scopre nella profondità incerta dell’essere luce, concretezza, impossibilità. Come se fosse la fine delle parole che non si riescono più a dire, negli anfratti soffusi di mistero del nostro esistere immutabile, eterno. Nella metafisica dell’idea in sé, del sapere come viaggio senza ritorno dello spirito. Ritrovare così i frammenti dell’Esserci e di quella parola filosofica che ci consente ancora di credere e di sperare.
Ascolta l’episodio anche su Spotify
Comments
Condividi: