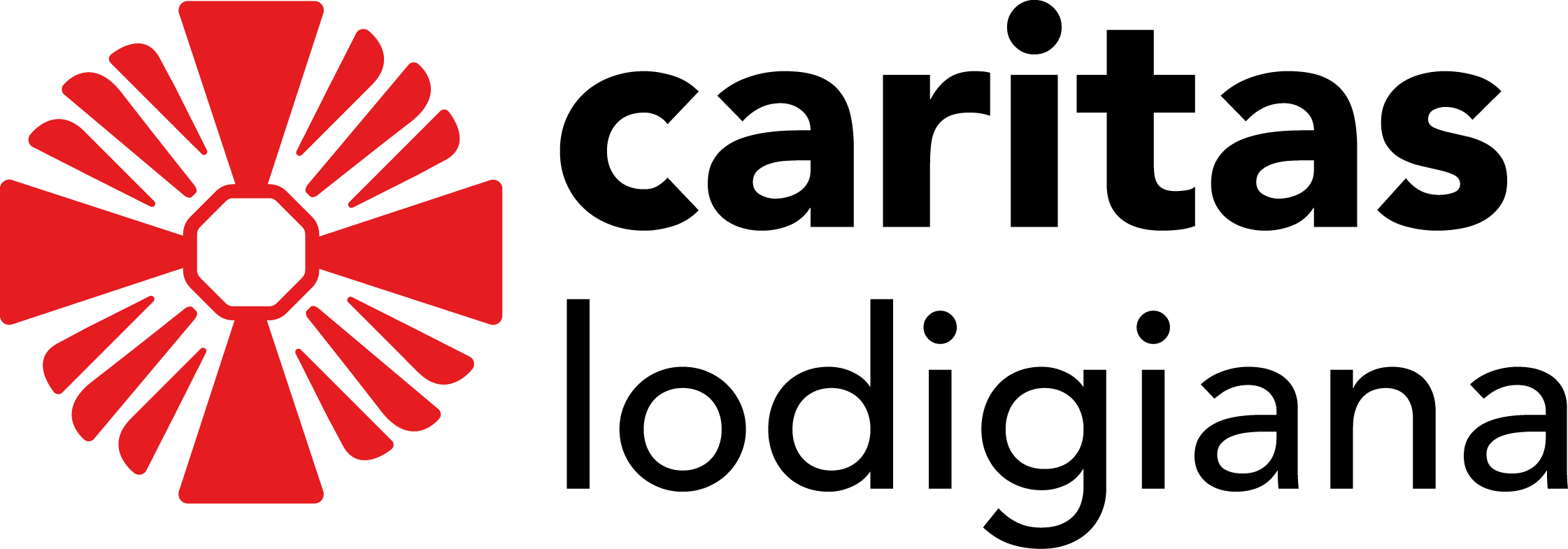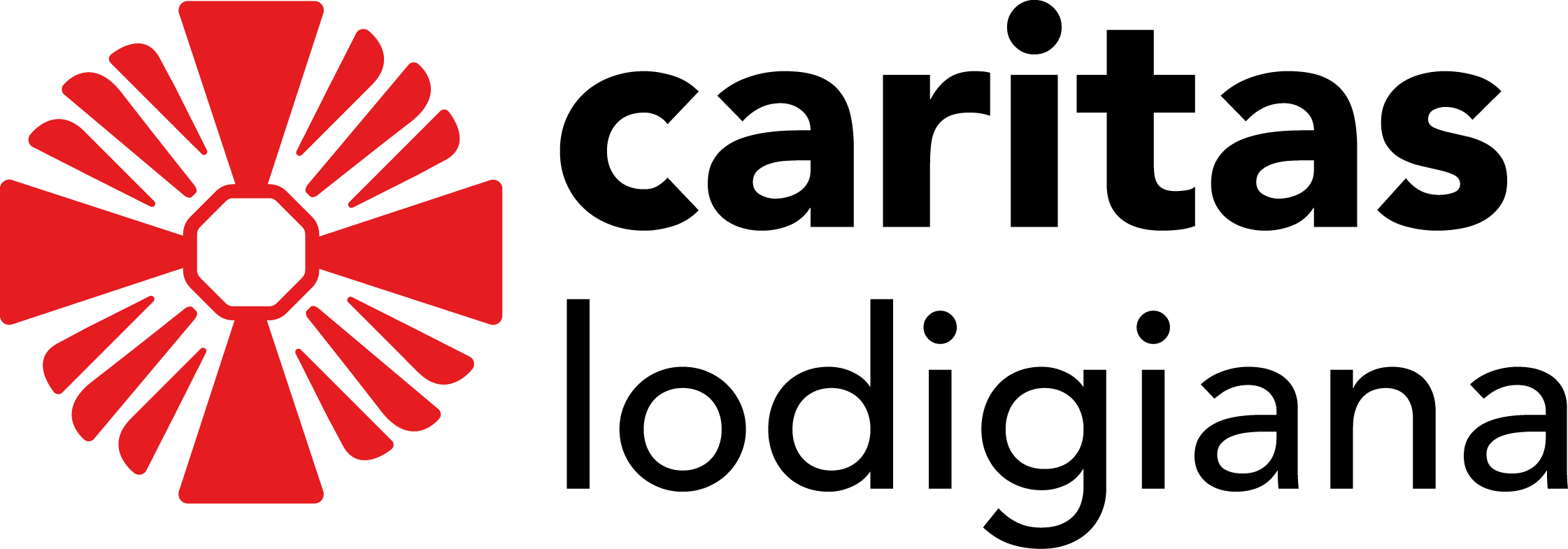Capitolo 3: Musica ribelle
- 18 Settembre 2023

Come si chiama il nostro tempo? Quale strada segue? Io non posso stare fermo, con le mani nelle mani, quante cose devo fare prima che venga domani…canto per la strada a bassa voce mentre mi dirigo verso la Mensa, o meglio verso il nostro luogo di ritrovo, con Mario, Jimmy e a volte qualcun altro che capita di lì e aspetta che il portone di legno si apra. La panchina della fermata della corriera, dove Via XX Settembre s’incontra con Corso Roma.
Giselle quando arriva e si ferma con noi è il segno che possano aprirsi le danze. Ho in mente quella chioma di capelli ricci e quella voce struggente, rotta dal dolore e dal suono del piano che canta Margherita adesso è mia. Mario mi sente e continua lui e se lei già sta dormendo io non posso riposare, farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare. “Il mio cantante preferito – dice – era Lucio Battisti, ma ho amato De Gregori, Battiato Celentano e anche i Pooh che ho visto dal vivo. Se ascolti Rimmel di De Gregori capisci che è un album perfetto, canti dalla prima all’ultima canzone!”.
Ha ragione Mario, la musica oggi non è più quella di una volta, i tempi cambiano e rispecchiano la loro consistenza o inconsistenza nella musica, nel cinema, nell’arte, nella cultura insomma. È lo specchio di quello che viviamo, la poesia che non c’è più nei testi, nelle immagini, nelle possibilità di significato. Ancora Mario “soprattutto le melodie, adesso non ci sono più. Tutto è elettronico, tutto è fatto a computer. Per me, che sono un musicista, non è poi così confortante”. “A me piace molto Battiato” dico “eh beh Battiato – continua Mario – io e lui siamo della stessa terra”. La musica ascolta nelle prospettive dell’anima quello di cui tutti noi avremmo bisogno: un po’ di umiltà, di compassione, di ricerca, di dialogo, un po’ di commozione. Si avvicina nel cuore e trasfigura quello che siamo. Intona “Dove vai quando poi resti sola? Il ricordo come sai non consola”. Io, continuo, “quando lei se ne andò per esempio, trasformai la mia casa in un tempio”. Ci guardiamo negli occhi, tutti e due un po’ sbiaditi, confusi, vivi nell’incertezza ma con la consapevolezza che qualsiasi tempo si debba vivere cercando di raccogliere nel cuore quello che brilla di luce, che sorride alla porta dell’esistere, che dona un altro modo di esserci. La parola come via che salva, che guida alla pace, che aiuta a sognare un mondo nuovo, a comprendere come siamo fragili davanti alla bellezza.
È la bellezza che salverà il mondo o noi che salveremo la bellezza? O noi che avremo il coraggio di proteggere l’arte e l’amore come gli unici legni di salvezza? Poi la poesia si interrompe: “ah, ancora con ste caso di cansun chi?” è Jimmy che non ce la fa più a sentire il canto e allora ci si ritrova nella risata come via della pace, salvifica, di ricerca di una nuova identità. È la musica ribelle, quella di quando si viene accusati per niente, di quando qualcuno ti parla alle spalle senza il coraggio di dire chiaro e tondo quello che si prova. Non voglio ritrovare il tempo del non respiro, rispondere a quello che non si sa. Omar che solitamente quando mi vede grida il mio nome ridendo, oggi non lo fa. Si avvicina a testa bassa, non dice niente. Prende il suo vassoio e si siede, poi quando ha finito butta via gli avanzi e se ne va. Senza salutare.
È arrabbiato con me, lo so bene. Ma non ci posso fare nulla.
Certe volte forse la rabbia fa ragionare, ci fa capire se siamo nel torto o meno, se abbiamo sbagliato, dove dobbiamo migliorarci, che cosa possiamo fare per cambiare. Io non riesco mai ad avere una cieca fiducia in tutto quello che faccio, in come mi pongo, nelle strade che perseguo. Ci vogliono dei momenti in cui fermarsi e ripensare a quello che si è fatto, a come ci si è comportati può portare a conclusione positiva, può ricondurre nel cerchio dell’esistenza nel moto liberatorio dell’Essere. Lo stesso Socrate diffidava molto da chi assicurava di avere tutte le verità in tasca, la domanda, arché originario, primo motore immobile delle cose, diventava il mezzo per cadere nella trappola della parola, per raccontare del corpo dell’uomo come una prigione, come un’impossibilità.
Facciamo fatica ad essere e invece bisogna trovare il coraggio di Diogene, filosofo errante, che andava in giro per le strade di Atene con una lanterna accesa e la luce del pieno giorno a chiedere: “cos’è l’uomo?”.
Lo prendevano in giro, era uno che viveva ai margini, solo, povero, senza niente, con la consapevolezza che farsi delle domande certe volte aiuti di più che avere delle risposte, che il solo interrogarsi e ricercare permetta di non interrompere mai il continuo ciclo della vita e della natura che è tempo e necessità sociale. Così è per me e spero che lo sia per Omar, anche se è difficile e spesso la fragilità di cui siamo fatti ci annebbia la vista, non riusciamo più a vedere le cose dalla giusta prospettiva. È arrabbiato con me perché l’altro giorno non voleva alzarsi per prendere la macedonia ma a tutti i costi chiedeva che io andassi da lui, gli prendessi il bicchiere, glielo riempissi, mentre stava comodamente seduto al tavolo.
Perché devi fare così? Perché gli altri devono alzarsi e tu no?
Così è finito il nostro rapporto di relazione e condivisione, di tempo, di sguardo, di ricerca. Magari ci ripenserà, ma non possiamo pregare nessuno per stare con noi e il ruolo è anche quello di dire di no, qualche volta. Grazie, grazie per le sinfonie del tempo, perché in questo modo si capisce crescendo quanto dolore, quanta incertezza, quanta impossibilità e quante volte dobbiamo tornare sui nostri passi ricominciando da capo. La carezza della sera che diventa immagine concreta e radicale per descrivere quello che siamo non so più che sapore che ha, quella speranza che sentivo nascere in me. La speranza di una vita nuova, diversa. Non sappiamo se ci manca di più quella Carezza della sera o un altro modo di vivere, di sperare. Sognando un mondo come Mario, in cui tutto non sia solo silenzio di televisioni, voci sfocate, tentativo infallibile di dominio strumentale, di quel sentimento che fu giù illuminista e poi positivista che ha tentato di ridurre l’uomo a una macchina.
Ma nel ‘900 va in crisi tutto, anche i valori certi della matematica, è un secolo nuovo, in cui si è appesi tra il tempo e la vita, nel sogno e nella veglia come in quelle prospettive espressioniste di Matisse e la famosa Danza del tempo e dei ricordi. In cui chiedersi: Da dove veniamo, chi siamo, dove andiamo? come Gauguin non è nient’altro se non lecito e necessario. Comprendere anche ciò che è incerto, sapere che l’unica certezza sia quella donna seduta in posizione fetale, con le mani sulla testa a indicare la morte, il tentativo ultimo, il viaggio senza fine di un domani che ci spegnerà. Che ci lascerà senza respiro.
Ci siamo: soli, abbandonati, figli dei giorni appassiti, come foglie di tigli d’autunno, come una nuova prospettiva dell’esistere. Non solo Mario, Jimmy e il volto arrabbiato e, probabilmente, deluso di Omar, ritornano alla mente tra i pensieri, le parole, le pagine, ma anche Konateh, giovane senegalese. Alto, sorridente, il viso è protetto da un po’ di barba e la testa brilla con il sole d’estate, lo avvolge, ricerca il tempo e la vita. Un giorno mentre passo vicino al tavolo dove sta mangiando insieme al suo amico Sillah, per portargli una brocca d’acqua, mi chiede “Ma tu dove sei nato?”
“A Lodi” gli rispondo io.
Allarga le sue pupille nere con un’espressione stupita. Non è il solo, anche i ragazzi, minori stranieri non accompagnati, a cui insegno italiano, spesso dicono che sembro, forse per i tratti somatici, un africano di pelle bianca, chiaramente. Libia, Marocco…
Sarà, può anche darsi, ma non credo che in Africa parlino molto il dialetto lodigiano. Poi mi siedo con lui e ci confrontiamo, mentre sorride e mangia con la bocca aperta, il riso bianco che ha l’impressione di non essere proprio buonissimo. Ma c’è il gusto tra i denti, la bocca e il gesto di allungarsi in una stretta di mano, in un segno di affetto, di riconoscenza. Parliamo un po’ del Senegal e delle questioni politiche che attanagliano il paese in una corsa per la difesa della democrazia. Poi della religione, di Touba, del viaggio come speranza.
Ancora una volta si stupisce “come fai a sapere tutte queste cose sul Senegal?”
“M’interessa molto”
Poi prende il telefonino e mi fa vedere qualche foto del paese, di casa, della sua famiglia “questa è la mia prima moglie e questa la seconda – dice – qui i miei figli”. Come può regalare il tempo quello che siamo e quello che abbiamo bisogno di diventare, di continuare a credere, di sperare? È il Vangelo, la strada per raccogliere il fiato, per riscoprirsi parte integrante della vita, dell’amore di Dio, per non smettere mai di ricercare il motivo per vedere il sacro, per commuoversi, per sentire la grande bocca che narra le storie dei nostri ricordi. Come Konateh che vive appeso a quello che non sappiamo, che con la terra nel cuore, ama parlare e ridere, vivere e credere nel cambiamento, nella possibilità di una relazione vera e sincera con il domani. Tutto questo dona il canto e riporta alla mente le prospettive di Cat Stevens, in una poesia, sul destino, sul tempo, sull’essere figli della nostalgia e della fede, sul coraggio che c’è e che spesso manca.
It’s not time to make a change
Just relax, take it easy
You’re still young, that’s your fault
There’s so much you have to know
Find a girl, settle down
If you want, you can marry
Look at me, I am old, but I’m happy.
Ascolta l’episodio anche su Spotify
Comments
Condividi: