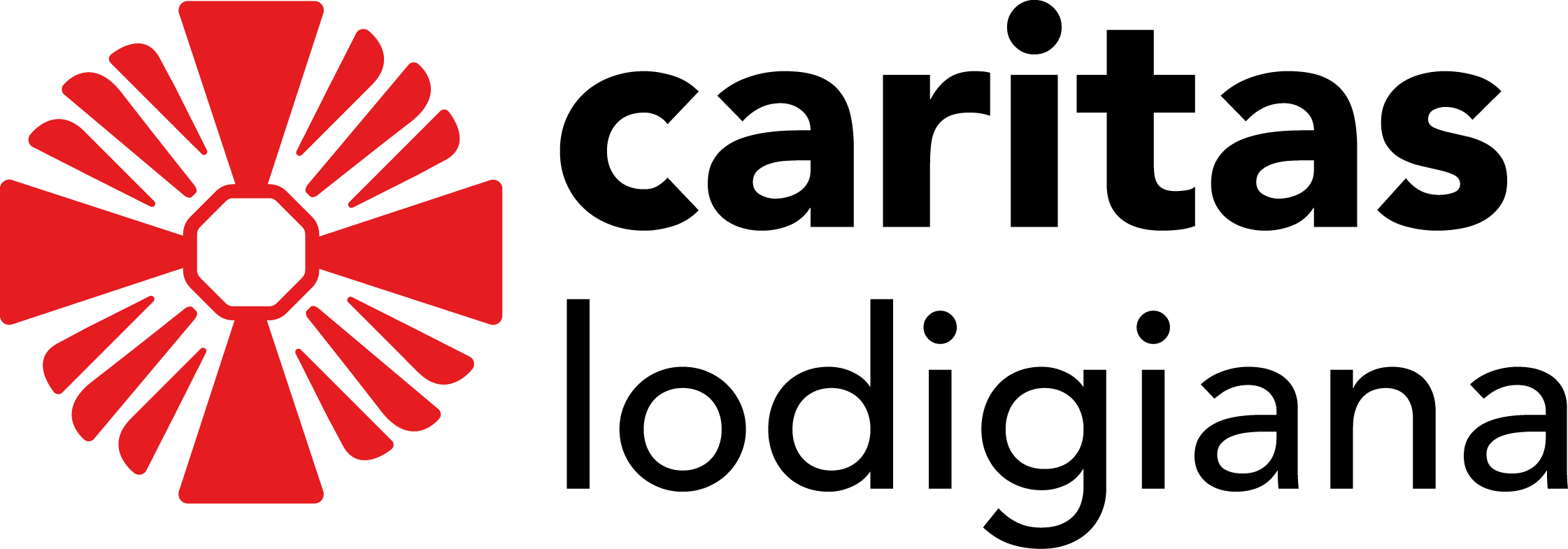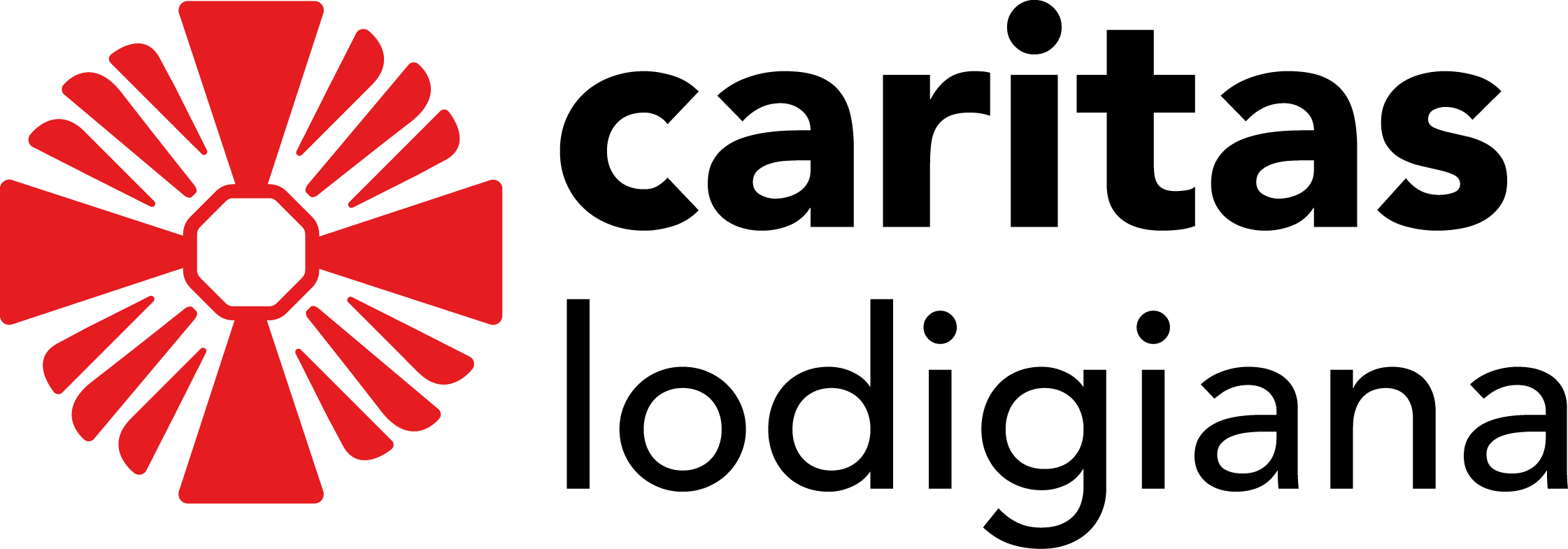Capitolo 10: Konateh
- 13 Novembre 2023

Il suo sorriso è luce di sole d’estate, fiume che abbraccia città e tramonti, luoghi perduti, orizzonti per domani di fiato. Konateh Soaibu è alto, pochi capelli e un filo di barba che accarezza il mento e si apre in uno sguardo penetrante che arriva dritto all’anima. Sembra di essere amici da sempre, di incontrare un uomo che conserva nel cuore in modo prezioso quello stesso Fanciullino di Pascoli che è la capacità di commuoversi e di emozionarsi davanti alla vastità della vita, qualsiasi cosa succeda. Con i piedi dei sandali vuoti, tra la nebbia e le nuvole, appesi sul filo del cielo, tra i ricordi. C’è nel volto di Konateh una sorta di magia, un velo sottile di commozione che permette di perdersi nella sua profondità, che guida a quello che ancora non sappiamo, sulla strada apparente di una soluzione trovata. È nato in Senegal, a Casamance, precisamente nel paese di Velingara, da padre senegalese e madre gambiana. Ci incontriamo ai giardini di Lodi, abbracciati dalle piante e dalle zanzare che non lasciano un attimo di tregua. Così, mentre parliamo il ragazzo cerca di allontanarle e di proteggermi dagli insetti che si posano instancabilmente sul corpo.
L’aria è leggera, il caldo torrido sembra essere passato, ma siamo ad agosto è forse non è ancora il momento di cantare vittoria. Certo un po’ di vento è quello che ci vuole per prendere una boccata d’ossigeno, per sognare, come faccio io che apprezzo l’inverno, la nebbia fitta della campagna lodigiana, le foglie d’autunno, il maglione di lana, il freddo che avvolge le membra.
Konateh respira a pieni polmoni ogni volta che il vento ci accarezza, distende le braccia, chiude gli occhi e sorride. Lo guardo e ha in sé la forza espressiva che sprigiona il teatro, quello che non ha bisogno di copioni, di battute finte, che è fatto di gesti, di movimenti, di inclusione, di musica, che abita le strade, le piazze, le periferie del simbolico. Così come scriveva Peter Brook a proposito di Grotowski … per Grotowski il teatro non è questione di arte. Non si tratta di opere, produzioni, rappresentazioni… è qualcos’altro. Il Teatro è uno strumento antico e di base che ci aiuta con un unico dramma. Il dramma della nostra esistenza. E ci aiuta a trovare la strada per la fonte di ciò che siamo. Cerchiamo la strada per ciò che siamo, ci abbeveriamo alla fonte di Dio, ragione oggettiva del tempo e della consapevolezza dell’arte e della poesia. Si racconta Konateh e lo fa ricercando tutte le parole possibili che sa di Italiano e cerca di farsi capire gesticolando.
Con enfasi quasi mistica si riconcilia con il tutto della speranza e parla del suo passato, del viaggio, della vita e dell’attualità che risuona forte nella città di Lodi, intreccio di strade e di sogni. La nostra è una chiacchierata itinerante, infatti abbiamo appena iniziato a parlare e il suo telefono inizia a squillare. È il fratello che ha bisogno di una ricarica per il cellulare.
Così ci spostiamo dai Giardini Barbarossa a Via Lodino per raggiungere il negozio dove può spedire i soldi in Gambia. Mentre camminiamo ho il quaderno a portata di mano e tra uno sguardo e l’altro d’intesa registro i suoi ricordi, le voci, i frammenti e le parole che fanno capolino a poco a poco dalla bisaccia della vita, come se fosse il cielo carico di stelle la notte, l’esistenza che ricomincia, senza farci caso.
“Io sono nato nel mese di Gennaio del 1994, questo so da quando sono qui in Italia, ma non ci credo, secondo me sono più vecchio” scherza, chiudendosi in un abbraccio, poi inizia a raccontare delle radici.. “Tutta la mia famiglia è musulmana da sempre, mio papà infatti ha sposato quattro donne, così siamo moltissimi fratelli e sorelle. A Casamance le cose non vanno benissimo, il contrabbando è veramente all’ordine del giorno e fenomeni come lo squadrismo e la presenza di bande stanno prendendo sempre più piede. Ricordo molto bene quando a mio padre rubarono le mucche. Arrivarono in massa, imbracciando un fucile e fecero piazza pulita di tutto quello che avevamo”. Sono emozioni ancora vive nella mente di Konateh anche se ormai è passato tanto tempo. Non è piacevole perdere tutto, soprattutto quando quel tutto significa l’unica fonte di sostentamento per una famiglia. “Ho sempre lavorato la terra, coltivavamo le arachidi e avevamo anche tantissimi alberi da frutto – dice, mentre mi fa vedere sul telefonino le immagini delle vaste distese d’erba della loro proprietà – il momento più bello della giornata era quando alla sera tornavamo a casa, stanchi e sudati e mangiavamo tutti insieme”. Passa da un argomento all’altro Konateh e all’inizio faccio fatica a seguirlo, poi mi abituo. È come un continuo flusso di coscienza, di ricordi, di responsabilità, con il desiderio di raccontare, di parlare, di condividere, di ricercarsi parte integrante dello spirito. “Potrei dirti che il mio cibo preferito sia Ceebu Jen, ma non è così, a me piace molto il Domoda. La vita nei campi era dura, non c’erano tutte le macchine di cui usufruite qua. Noi avevamo solo la falce e alla fine della giornata i calli sulle mani si facevano vedere”. È il simbolo del pane, del grano, del lavoro, della condivisione, della solidarietà, dell’esperienza fenomenomenica che diventa trascendentale, che si staglia all’orizzonte sul mare della nuova socialità. Ripensa a quando le cose per lui e la sua famiglia andavano bene, arrivavano da tutte le parti per comprare i frutti del loro duro lavoro, dalla Guinea e dalla Liberia, per esempio. Poi il ragazzo ha deciso che era arrivato il momento di cambiare vita, così è scappato in Libia per lavorare come idraulico.
Attraversando il Mali, il Burkina Faso, la Nigeria. Guadagnava anche molto bene, aveva un appartamento in affitto e poteva pagare tutto ciò che era necessario. La vita in Libia però non era come l’aveva sempre immaginata “là la situazione è diventata complessa soprattutto dopo la morte di Gheddafi, i prezzi sono saliti alle stelle e la tensione è aumentata. Se sei nero non hai vita facile, pensano di non essere africani in Libia solo perché la loro pelle è di un altro colore, ma non si rendono conto che lo sono anche loro, al 100%”. Così ormai in territorio libico non poteva più tornare indietro, non c’erano altre alternative se non partire. Nel 2014 si è imbarcato sulla prima nave per arrivare qui in Italia. Non riesco a domandargli del viaggio, per cercare di capire qualcosa di più; ci sono delle ferite che sono ancora aperte, che fanno fatica a rimarginarsi, che possono condurre a non risvegliarsi dalla sete. È meglio solo ascoltare certe volte, riuscire a entrare nell’altro anche con uno sguardo, con una stretta di mano, con una parola. Lascio così che sia lui a dirmi ciò che vuole, pronto ad accogliere. “La nave era piena di persone, tantissime, provenivano da tanti paesi diversi, era come se su quella barca ci fosse l’Africa e non solo, come cerchio di un nuovo modo di vedere le cose e di riconciliarsi parte integrante della propria fragilità. Se mio papà fosse stato ancora vivo, non mi avrebbe mai permesso di compiere questo viaggio”. Iniziamo a camminare, verso Piazza Castello per dirigerci in Via Lodino, nel negozio indiano dove potere mandare i soldi al fratello, che è in trepida attesa. Intanto inizia a raccontare del Senegal, delle sue radici, del tempo che è ritorno e metamorfosi dello spirito nietzscheana, da Leone a fanciullo, sulla via della sera, in quel campo deserto dopo il dolore, dove si può aspettare quello che verrà e di cui abbiamo bisogno. “La mia etnia religiosa non è Murid, come in alcune parti dell’Africa, dove oltre a seguire gli insegnamenti del profeta Mohammed, seguono anche quelli di Cheikh Ahmadou Bamba e degli altri suoi discendenti, ma Al Sunnah. Nel nostro nome c’è tutto: nient’altro se non Mohammed. Solo lui è il profeta per eccellenza, la guida, quello che con i suoi insegnamenti ci permette di intraprendere la strada verso la verità, per il paradiso, Jennah, in Arabo, luogo ultimo della pace dei sensi, dove lo spirito può finalmente liberarsi dalla carne e ritrovare la strada di casa”. Il Senegal per Konateh è rifugio sicuro, il porto sepolto del cuore, dove ha lasciato una moglie e un figlio, che lo aspettano sempre “sono tornato a dicembre, sono stato lì tre mesi, è stato bellissimo”. Poi mi fa leggere un po’ di messaggi che ha scambiato con la moglie Fatima in questi giorni, del dialetto senegalese Wolof con cui scrivono capisco poco o niente, ma la mia attenzione è rapita dalla foto di loro due insieme, che si abbracciano, mentre indossano degli abiti tradizionali, colorati a quadretti bianchi e blu.
Attorno a loro i colori dell’amore, la pace dei sensi, il sorriso della relazione che continua a splendere. “Vorrei comprarle delle luci perché ne ha bisogno – mi dice – come quelle che si mettono sugli alberi di Natale, le userà per illuminare la stanza”. “La mia regione Casamance è famosa soprattutto per la rarità delle piante, ce ne sono tante che utilizziamo per curare le malattie del corpo. Come non parlarti, poi, del burro di Karitè, tra queste. Le donne lo usano sempre per massaggiare la pelle dei neonati”. Il lavoro nella vita di Konateh qui in Italia è per fortuna, sempre stato una costante. Non lo ha mai abbandonato. Prima a San Zenone, poi a Melegnano, a Casale e infine a Borgo San Giovanni. Nella sua profondità però, oltre ai colori dell’Africa, c’è spazio anche per Lodi che lo commuove sempre, ogni volta che la guarda, come se fosse la prima volta, anche se fa fatica a orientarsi. “Qui dove siamo?” mi dice confuso mentre camminiamo in Corso Umberto. “Vedi – gli spiego, mentre ci avviciniamo al punto in cui Corso Umberto I sfocia in Via Lodino – lo capisci dal nome della via segnato su queste targhe”. “È strano per me, non riesco ancora a comprendere bene questi meccanismi, in Senegal infatti non ci sono i nomi delle strade, se bisogna darsi un appuntamento lo si fa in base a una determinata zona, o a un negozio che si conosce”. Poi scivoliamo nella via multietnica e usciti dal negozio indiano, ci dirigiamo verso il fiume. “È una delle mie zone preferite della città. Quando ho del tempo libero mi piace molto sedermi a riva, a piedi scalzi, e passare le ore ad ascoltare il suono dell’acqua, il suo scorrere senza fine”. Attraversare le epoche della propria vita, come avrebbe scritto Giuseppe Ungaretti, a ridere e a piangere con il sole d’estate. Senza il tramonto dell’anima e dell’interiorità con la Fede certezza assoluta. Ci fermiamo un attimo a osservare una vetrina di una macelleria araba. “Vedi – mentre indica con una strana espressione una teiera tipica – questa la usiamo per il the, come il Kenkelibà, ma qui costa tanto, come queste pentole per il Cous Cous. I prezzi sono proprio esagerati”.
Camminiamo lungo l’Adda e dopo aver incontrato qualche viso amico per caso, ci sediamo e restiamo qualche secondo in silenzio ad ascoltare il rumore del vento tra le foglie e l’acqua che riflette la luce del sole. Per Konateh la religione è qualcosa di fondamentale, gli scorre nel sangue, è la preghiera come fine salvifico dell’esistenza, come possibilità reale di quello che siamo e che possiamo diventare.
Recita a memoria alcuni versi del Corano e me li spiega con la convinzione e la certezza di ritrovare dentro di sé la profondità spirituale di cui tutti noi abbiamo bisogno, poi commenta in modo infelice l’immoralità dei tempi in cui siamo immersi, l’assenza di valori, che è il sinonimo dell’inconsistenza e della generalità perbenista. “Mi capita molto spesso di vedere ragazze che vanno in giro con la schiena scoperta, quasi mezze nude, com’è possibile che si tollerino atteggiamenti simili? In Senegal verrebbero puniti immediatamente. La donna ha dentro di sé la matrice della parola rispetto.
È fiducia, responsabilità, cura, legame indissolubile con gli altri. La religione non dice di vivere in modo dissoluto e provocatorio, andando in giro a disseminare la propria sfacciataggine, ma di comportarsi con mitezza. Si è forse perso il senso della moderazione, dell’attesa, dell’umiltà. Credo che sia sempre tutto dato per scontato”. Conclude mentre si alza e con le parole e la sua espressività è capace di colorare anche le giornate più inconsistenti. Konateh è un uomo profondo che, anche se vive in bilico, non smette mai di ricercare l’equilibrio definitivo e di sognare. “un giorno vorrei che mia moglie, mio figlio e la mamma potessero raggiungermi qui in Italia. Quello che resta della famiglia riunita. Avevo già chiesto a mia mamma di venire qualche tempo fa, ma ha voluto aspettare, non voleva lasciare gli altri figli da soli. È giusto così”. Non apprezza il ragazzo, inoltre, gli atteggiamenti che spesso gli capita di vedere di rabbia dei fanciulli nei confronti dei loro genitori.
“Se io mi fossi permesso di insultare i miei parenti, di ribellarmi loro, mi avrebbero messo in una stanza, legato e preso a frustate. In Senegal funziona così, il rispetto è la prima cosa”. Sono le 18:20 e siamo di nuovo in cammino io e Konateh, come se tutto il pomeriggio passato insieme non fosse ancora abbastanza. “Ah, è già ora della Mensa?” mi chiede mentre siamo costretti a lasciare i nostri posti e a incamminarci verso la porta di legno, dove si passano le vite e le stagioni, dove si accolgono le anime. C’è una vita da condividere, uno stesso tratto di strada, un sogno che ci accomuna, il filo da seguire e da tracciare sulle strade del presente, nel tempio della solitudine, del ricercarsi, dell’essere parte integrante, vera e viva dell’identità.
Oggi, ancora domani. Con la speranza di poter raccogliere i frammenti di quello che siamo, ciò che rimane della vita, dell’esperienza, del passato. Quello che per chi vive la fragilità e la socialità è il cammino più difficile da seguire. Scrivere e ripensare agli occhi profondi di Konateh, al suo sorriso che s’impregna di Africa nera, che coinvolge, che cancella anche per un solo istante il dolore, diventa il fine per riconoscersi nel sapere, nella saggezza, nella cultura come arte radicale per cambiare le cose, come via principale per essere padroni di se stessi, per poter prendere parte finalmente alla propria vita. Abbiamo bisogno di persone che si radichino nel dialogo, nell’ascolto, nella ricerca senza fine che, senza tanti facili moralismi, ci prendano la mano, l’esistenza, l’anima, per sapere di essere nella stessa parola. Poi continuiamo a parlare mentre ci spostiamo alla Mensa, della musica tradizionale senegalese, che canticchia piano, ancora della Fede e della spiritualità, delle strade che servono per giungere al principio primo, motore immobile del tutto. “È Dio il creatore del Cielo e della Terra, colui a cui si fa riferimento. Ci sono diversi modi di arrivarci, tante strade, ognuno sceglie quella che preferisce: Islam, Cristianesimo, Ebraismo, ma alla fine l’obiettivo è uno, in comune. Sulla scia di Abramo, del suo amore senza fine, figli di Adamo, del giardino del peccato.
Più soffriamo, più ci avviciniamo a Dio, più il nostro tempo vibra di luce”. Adesso Konateh, ospite da un amico, sta cercando una casa tutta per lui dove poter stare, in modo da non dover più venire alla Mensa che non è semplice diritto al cibo, ma luogo di socialità, finestra di passaggio verso un nuovo domani. “A San Zenone ho incontrato Sillah, a Casamance abitavamo vicini, passavamo le giornate insieme, poi ci siamo persi di vista e adesso viviamo a Lodi e mangiamo tutti e due allo stesso tavolo. Pensa che coincidenze, siamo sempre stati amici fraterni e lo siamo ancora”. È anche questa la forza espressiva di un luogo che unisce, anche se a volte sembra dividere, che diventa centro di relazione, di scambio, di partecipazione, di concettualità conoscitiva e pura. Un posto dove ci si perde e ci si ritrova, dove alcune prospettive si realizzano e altre restano ferme, davanti a un piatto di pasta, dove si piange di dolore e si scherza, dove il giorno tramonta nella sera e il silenzio risponde. Scherzano spesso i due, li vedo alla Mensa mentre si scambiano strette di mano, pacche sulle spalle e parole, mentre chi finisce prima dell’altro, si siede paziente sulla panca all’ingresso per aspettare, quando condividiamo insieme il messaggio dell’identità. Abbracciato dal Fiume e dal pomeriggio d’agosto Lodi si ricorda giovane, vera, nonostante gli anni sulle spalle, diventa ancora una volta il perché, la domanda che ci si pone a ogni incontro, a ogni relazione, a qualsiasi abbraccio, tra gli alberi verdi, sul tetto di fiori di tigli, nel cielo che vibra di sale. Abbiamo attraversato le epoche della nostra vita, sorriso al dolore, per ritrovarci, per nasconderci là dove nessuno vede, all’addiaccio delle vite vissute, per scoprire che nel profondo del nostro cuore, negli anfratti raccolti di meraviglia, ci sono gli angoli di uomini celesti in fila per il tempio della sera, che scrivono versi di luce, che si raccolgono in abiti bianchi, lunghi di seta, che respirano il tempo. Troppo confusi, incerti, soli, tristi, impegnati, ma vivi. Così come con Konateh amici da poco e da sempre, eterni migranti al mercato del sole, per una beatitudine senza confini.
Ascolta l’episodio anche su Spotify
Comments
Condividi: