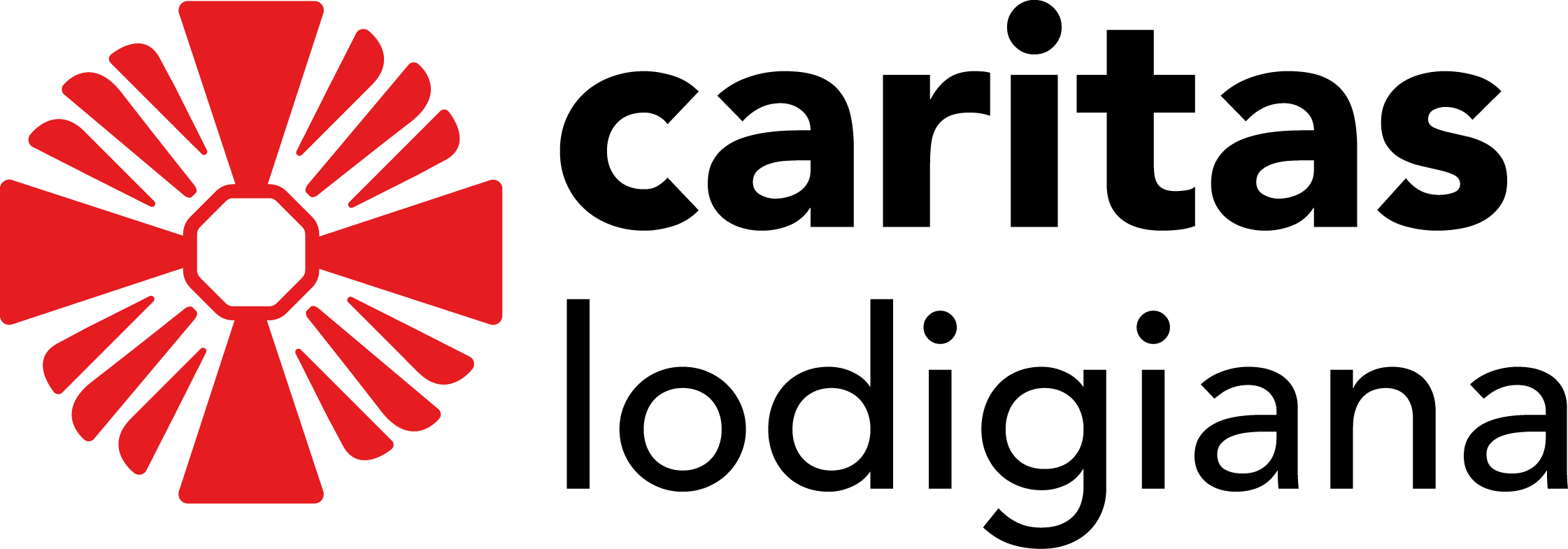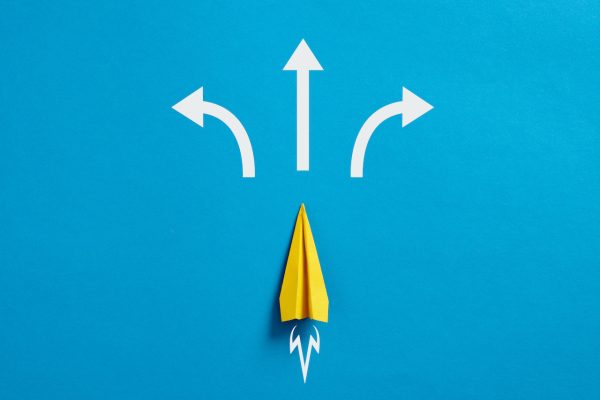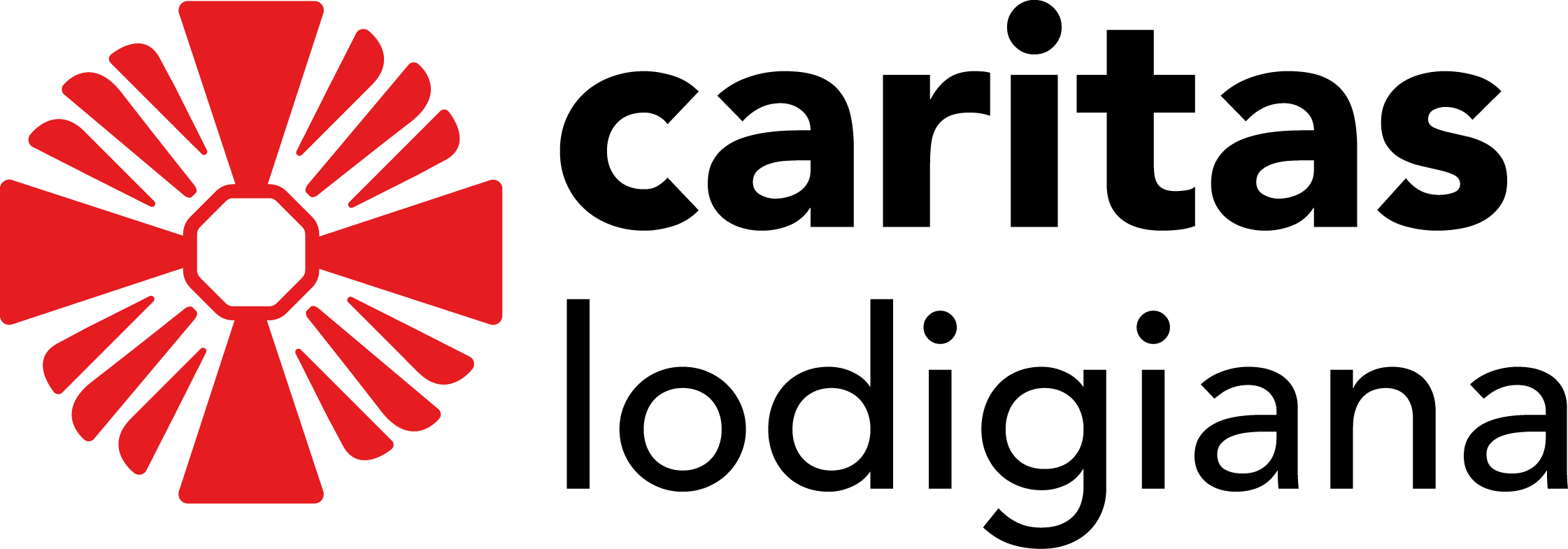Capitolo 8: Prima che il sole tramonti
- 23 Ottobre 2023

Usciamo dalla Mensa dopo il turno di giovedì mattina. Oggi ho lavato i piatti e sulla maglietta porto ancora i segni del detersivo e dell’acqua. Sembra che io abbia lottato con le stoviglie, invece solamente con il destino, la speranza e la necessità di continuare ad aprire gli occhi per guardare la vita, il tempo che scorre e che non torna, i giorni tutti uguali e diversi.
Io e Giselle troviamo sul davanzale della finestra una buccia di banana “non può essere stato Tsing – dice – non è solo lui il matto, tutti quelli che vengono qui a mangiare sono un po’ fuori di testa”. Ripenso all’atteggiamento aggressivo e abbandonato di Tsing, agli occhi vuoti e socchiusi di Diamanka, alla risata folle di Omar, alla mania accumulatrice di Jimmy, a Mujib che rompe ogni cosa che tocca, che si toglie le scarpe e picchia i piedi sui sanpietrini bollenti di Corso Umberto, che si risveglia con il sale del tempo perduto. O ancora, a Mario e le sue frasi sconnesse e ai discorsi di Mohammed che faccio fatica a mettere insieme, pezzo dopo pezzo. È vero quello che dice Giselle: vivere la povertà non è facile, confonde, conduce sulla strada della perdizione, senza vie di fuga, senza possibilità di ricerca nuova.
Essere poveri, abbandonati, soli, indifesi, lontani dagli occhi e dall’attenzione della gente illude, ma quale strada dobbiamo seguire? Quanto tempo rimane all’uomo che deve ricercarsi continuamente nel futuro fatto di fiato, di pane spezzato, di fatica? Un sorriso, una stretta di mano, un abbraccio come fine salvifico dell’esserci, come spinta a sentire pulsare la vita nel cuore. Già troppo grandi, vivi nel vuoto della dimenticanza. “Devi imparare a costruire il tuo avvenire” sento che una mamma dice alla figlia adolescente mentre cammino per la strada… Ci penso un attimo e poi mi giro verso di loro e intervengo nella conversazione con un po’ di incertezza e nostalgia “l’avvenire non è mai facile”. È vero, non è mai facile, la signora mi guarda e risponde “si ma ognuno deve costruirlo”.
Dovere, scriveva Immanuel Kant, nome sublime e grande! Fosse tutto così facile, la signora con il rossetto, la borsa di marca e la messa in piega appena rinnovata, avrebbe ragione.
Questo dovere che ci permette di andare al di là di ogni ostacolo, così come lo intendeva il filosofo di Konigsberg, che è via per l’Io Penso, forma a priori e necessità del fenomeno. La guardo un attimo cercando una risposta adeguata che non trovo e allora saluto e continuo il cammino. Mi sovvengono alla mente le immagini della stanza di Via XX Settembre, anche lì quelli che si siedono sulle sedie e consumano i loro pasti ogni giorno, avrebbero dovuto costruire il loro avvenire, non avrebbero dovuto fermarsi sulla strada dei tigli. Invece la vita non dipende solo da ciò che vogliamo noi, ci prende e ci sbatte contro un muro e allora è lì che dobbiamo avere il coraggio di rialzarci, di asciugare le lacrime e con gli occhi del cuore essere spettatori partecipi del destino. Però c’è chi non ce la fa, chi cade, chi si perde nella follia, chi fa di un ponte la propria casa e questo gli basta. “È inutile trovare un lavoro a questo – mi dice Silvana mentre siamo insieme al dormitorio di Via Defendente per il nostro turno del mercoledì pomeriggio – non vuole lavorare, sta bene così”.
Tutti noi dobbiamo avere un sogno nel cassetto, che può salvarci, che può darci la convinzione e la forza di continuare ad affrontare le sfide del tempo, i cambiamenti del domani. Ma, il mio, è che un giorno alla Mensa non dovremo più aprire il portone, le brocche d’acqua rimarranno nel frigo e le sedie appoggiate sui tavoli di legno. Quello sarà il segno per cui l’uomo potrà dirsi un po’ soddisfatto, in cui quel dovere kantiano sarà la via più grande e vera per la critica e la poesia, per l’essenzialità dello spirito e del ricordo. Poi, Giselle continua “Vedi come si comportano anche i ragazzi africani che noi ospitiamo nei progetti di Housing. Pensano sempre di vivere come se fossero in Africa, ma non è così, sono egoisti”. Ancora “Molti preferiscono mandare i soldi nel loro paese e dormire per la strada, piuttosto che stare al mondo con dignità. Ecco perché ti parlo di egoismo, altro che solidarietà africana. Non esiste”. È difficile accogliere altre culture, altri modi di pensare, di intendere la vita, di affacciarsi sulle finestre da pulire, sui cortili da respirare, sul vento della sera, del fiume, della luna.
Non posso non sentire vicine le sue parole, credere che tutto sommato Giselle abbia ragione, certe volte alla Mensa capita di assistere a immagini che ci fanno ricordare dell’egoismo e dell’avidità che molti si portano dietro. Scene di litigi perché a un ospite sono state date due banane, piuttosto che una, altri che dopo aver mangiato un piatto di pasta immediatamente corrono perché ne vogliono un altro, non importa che ci siano altre venti persone che come lui abbiano bisogno di mangiare, quello che conta è aver soddisfatto il desiderio di sazietà. O ancora ricordo Diamanka litigare alle docce con un altro africano perché si sono toccati l’uno con l’altro. Parole, discorsi, quasi ad arrivare alle mani. Silvana inizia a urlare “Via si litiga fuori, andate via”. “Fuori?” le chiedo. “Sì, così poi io chiamo la polizia e loro scappano”. Ci sono immagini che ci rendono pieni di insoddisfazione, ma non è solo questo, c’è la ricerca continua per il miglioramento, il credere che basti il respiro, che la luce della sera possa soffondere d’argento le prospettive eterne dell’esistere. Ecco l’egoismo, che non si mette da parte, soprattutto quando si è in una situazione di difficoltà, come lo stesso Omar, che mi mette il muso perché non ho accontentato la sua richiesta di riempirgli il bicchiere di macedonia mentre lui stava lì seduto comodamente. E gli altri? Gli altri chi sono, dove sono?
Cosa facciamo noi per gli altri? Me lo chiedo sempre, quando mi siedo con le gambe a penzoloni sul piano di lavoro dentro il cucinotto, con la testa appoggiata al frigo e li osservo mangiare. Certi giorni quando la parola è quasi assente, altri quando è fin troppa. Cosa siamo noi nella vastità della vita profonda e inspiegabile? Scrivo
Sorridi dolce e fragile primavera che siamo nella stessa parola vibranti di luce che il giorno ritorna nel vento e nel sole Cerca il fiume nel letto di mille lenzuola la mano dell’ultimo Dio sulla terra di foglie cadute Piangi dolce e fragile primavera.
Sorridi e piangi primavera appassita di luce, sulle sponde del fiume, dove canta la voce del pane e il silenzio del tempo che fugge, dove il sogno finisce e l’ultimo Dio sulla terra, vestito di bianco, alza gli occhi al cielo, sorride alla luna, dimentica il tempo che non c’è, il giorno della sera. Siamo nella stessa parola, tutti, nello stessa frase, virgola e punto. A capo del tempo, a capo dell’esistenza.
Il filo indissolubile della fragilità. La linea orizzontale che spinge verso la materia, quella orizzontale verso lo spirito, come in Inneres Auge e nella musica che si fa poesia e marginalità esistenziale della vita. Siamo nella stessa parola, con Amidou, Mamadou, Konateh, Ladji, Moussa, con tutti quelli che si tengono per mano, anche solo per un breve tratto di strada, che poi si guardano andare via e perdersi nuovamente nel mondo, con la nostalgia delle parole, della condivisione, dell’incertezza, ma con la consapevolezza del poter continuare a costruire ponti qualsiasi cosa accada. Oggi, ieri, domani, con il fiato che si fa strada nel mare, al confine dei sogni, da questa parte della riva e del tramonto. Così le parole di Giselle tratteggiano attimi di vita vera, i suoi vestiti dai mille colori che sfoggia alla Mensa, come abiti da sera, le storie e il silenzio da cui germoglia il seme della speranza, del giorno perduto e del cammino, continuo e finito, metafora esistenziale di quello che siamo, parentesi che traccia il modo di cogliere i passaggi di tempo e di spazio. Anime in eterno mutamento. È la sensazione che provo per un attimo, quando un mercoledì sera finito il turno alle docce passo per Via XX Settembre per tornare a casa e sento una voce che mi chiama da dietro. Mi volto, è Ladji che torna dal lavoro in bicicletta. Occhiali scuri e una maglietta arancione, mi stringe in un abbraccio, è di corsa ma scambiamo qualche parola.
Ha bisogno di un aiuto per trovare una casa in affitto a Lodi, il suo periodo di accoglienza nel progetto Housing Caritas presso l’appartamento in Via Morti della Barbina è terminato.
Così mi dice che per adesso andrà a stare quattro mesi a Massalengo dove lavora e poi tornerà qua a Lodi, sperando di aver trovato una sistemazione adeguata. Lo guardo il mio amico, riprendere la strada in sella alla sua bicicletta e penso se questa sia l’ultima volta che lo vedrò sfrecciare per le strade della città, condividere con me un po’ di vita, ricordarsi della certezza. In quei suoi occhi scuri, così profondi, che sembra come cenere di camino, di potersi perdere negli enigmi colmi di mistero della nostra anima. Poi proseguo la strada un po’ più solo e vuoto, passo davanti alla Mensa, fuori dal portone le tante bici degli ospiti, appoggiate una vicino all’altra. Non faccio in tempo ad andarmene che la voce di Giselle risuona forte “Ermanno” Mi apre la porta “facevi finta di non vedermi?” Ridiamo un po’ e mi avvicino al buffet dove i volontari stanno servendo, il mio sguardo cade sui cartoni dell’uva ammassati per terra e alcuni acini rimasti orfani, altri dispersi sul pavimento, altri ancora schiacciati. Li osservo mangiare, seduti sul tempo dell’attesa, nella casa del silenzio, nel sogno che non ritorna, vado a salutare Mohammed, un tunisino che sta mangiando seduto al tavolo con Diamanka e Ivan “Mi dai ancora una fetta di formaggio?” Nonostante sappia già la risposta, gli dico che deve chiedere a chi sta servendo, “io non sono di turno Mohammed” Poi mi rifugio nella dispensa finalmente da solo e scrivo nell’attesa di mistero, scrivo alla Mensa del pane spezzato di chi non ha niente e cerca futuro, di chi accoglie la vita come acqua chiara di torrente e di chi la rifiuta e la dimentica sulla strada della sera.
Scrivo di chi se ne va, di chi fugge, di chi cerca ancora di amare le parole, di proteggerle, di accoglierle nella porta del cuore, come fossero stracci di vento, frammenti di vetro.
Ancora, prima che il sole tramonti.
Andrai via anche tu tra gli acini d’uva vestito di mille colori sul tempo che non ritorna nei tavoli apparecchiati per la cena stringimi nel sorriso prima che il sole tramonti Andrai via anche tu dalle strade della provincia sola dal fiume dei tigli di pianto.
Ascolta l’episodio anche su Spotify
Comments
Condividi: