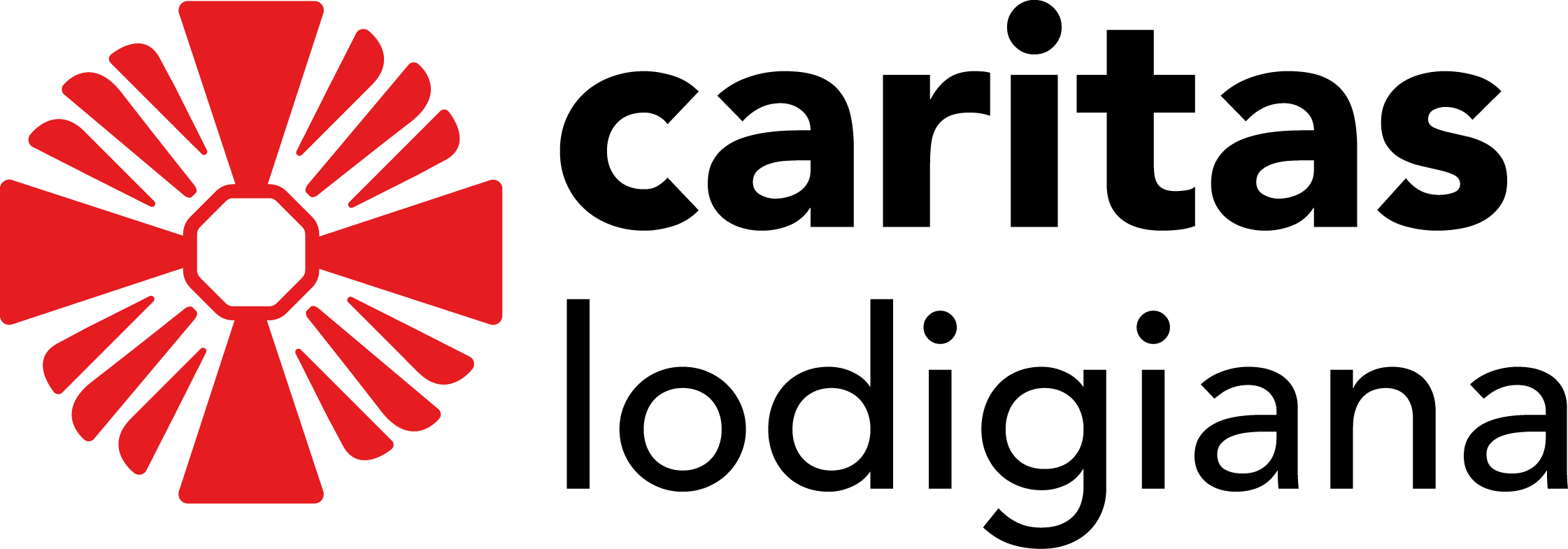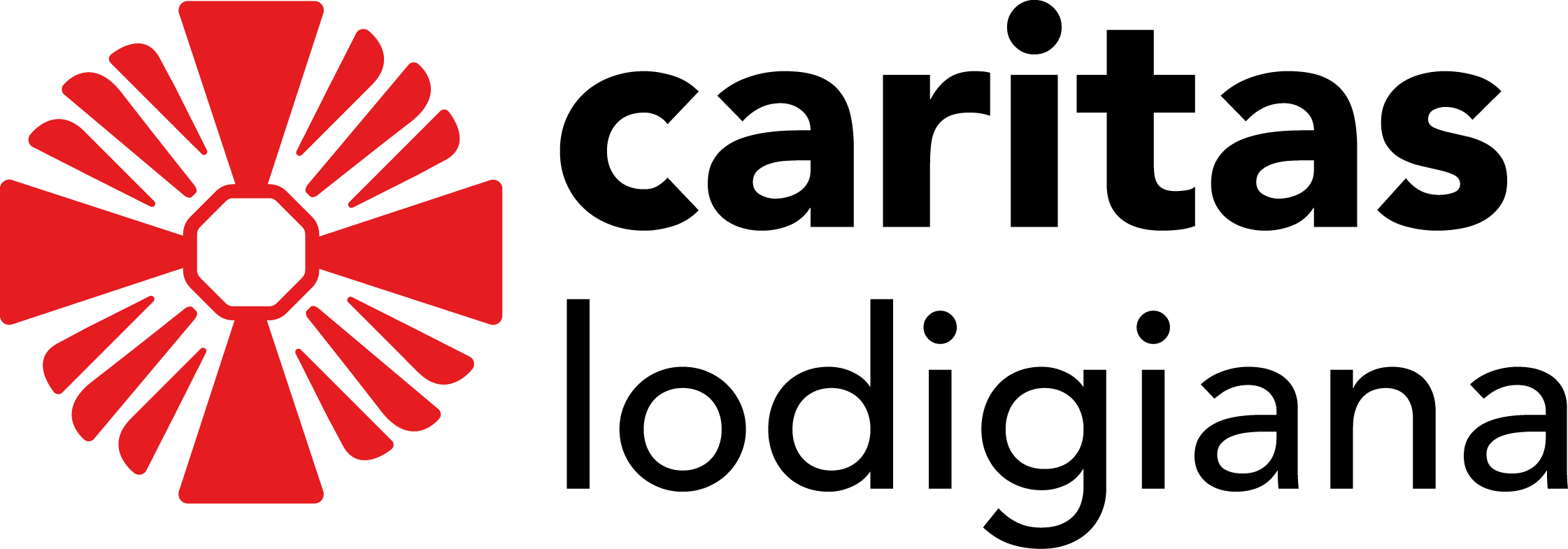Capitolo 4: Volti
- 25 Settembre 2023

Conservo ancora nella mente il ricordo di un servizio di un lunedì sera di inizio maggio. Il caldo già si accoglieva nel tempo e nel destino, nel silenzio.
Quella sera, per via di motivi di salute, c’erano alcuni volontari ammalati e quindi eravamo solo in tre. Prima di cominciare, mentre ero ancora da solo e preparavo i cestini del pane, della frutta ho guardato la sala da pranzo, vuota, nella penombra del pomeriggio che si scioglieva in tramonto e con gli otto tavoli disposti uno dopo l’altro, sempre nelle stesse posizioni, come ogni volta, con le sedie pulite appoggiate sopra. Una ad una le ho tirate giù e ho alzato un attimo lo sguardo, il soffitto e la luce sottile che riusciva a fare capolino dai lucernari. Così quasi per caso, nel tempo dell’attesa, della certezza di vivere l’istante nella profondità, così come Orazio Non tentare le tecniche babilonesi ho scritto parole su versi d’incenso, su quello che si vive spesso senza sapere il perché.
Bastava guardare il sorriso sparito
Negli occhi del mare
Aprire la porta alla pioggia, sedersi a mangiare
Alle spalle la croce del sogno
Futuro di spighe di grano e faticaCi sei anche tu con il tempo vestito di sete
Con i giorni sul cuore dell’Africa
Acqua che è tempo che scorre,
che fuggi lontano.
Bastava guardare il sorriso sparito negli occhi del mare, appeso alla croce del tempo, del pane spezzato, seduto su quello che non abbiamo più, nell’identità nuova dell’essere e del ricercare, in Cristo verbum caro factum est colui che si fa carne, parola, concreto trascendere e vivere.
Colui che ha seguito la voce del profeta, che si è fatto strada nella Città vecchia, ai margini, cantore della Buona Novella, dove una bimba canta la canzone antica della donnaccia, quattro pensionati sono al tavolino e il vecchio professore che va cercando in quel portone una che possa insegnargli la vita, che la notte cercherà con passione e di giorno umilierà con perbenismo borghese.
Sono gli ultimi, i soli, i poveri, quelli che hanno bisogno di essere trattati anche se non gigli, come vittime di questo mondo. Siamo noi che camminiamo su questa terra, con la forza e il coraggio di avere un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro. La poesia non è durata molto. Alle 19:00 apriamo la porta della mensa e gli ospiti iniziano ad arrivare, vassoio dopo vassoio, bicchiere dopo bicchiere siamo a corto di materiale. Per adesso siamo tranquilli, ma se dovesse arrivare ancora qualcuno…
Io e Licia, l’altra volontaria, ci guardiamo negli occhi e iniziamo a recuperare i vassoi sporchi per lavarli il più velocemente possibile. Suonano il campanello. Mi giro, la porta si apre e una decina di persone entrano parlando a voce alta. Corro da Licia, quasi ridendo dalla stanchezza e della disperazione. I piatti sporchi si accumulano e non sappiamo cosa dare da mangiare perché non c’è abbastanza tempo. Qualcuno se ne va via indispettito urlando qualche parola, altri rimangono e con pazienza aspettano il lavaggio e il cibo recuperato in frigo che deve essere riscaldato in microonde. Bisogna sapersi adattare, anche quando tutto è incerto e sembra complicato. Quando ogni cosa è difficile e il sogno della notte di tempo sembra non finire mai. Non mi piace lavare i piatti, ma chiaramente è necessario che qualcuno dei volontari lo faccia. Bisogna mettersi nel cucinotto, passare prima tutto a mano e poi poco per volta infilare dentro la piccola lavastoviglie che fa dei lavaggi veloci per insaponare e sciacquare nuovamente, ma in modo molto rapido. Questo però nega la relazione con gli ospiti, non si può parlare con loro, chiedere se abbiano bisogno di qualcosa, fermarsi un attimo a scherzare, a condividere qualche emozione. Si parla con il detersivo e con l’acqua. Però, ci sono momenti di sconforto, dettati dalla vita quotidiana, dai giorni talvolta crudeli e senza fine, che sembra ci prendano e rompano in mille frammenti. Sono proprio quelli in cui scappo nel cucinotto e lavo, ostinatamente. Come se fosse una cura, una medicina dolce per salvarsi dalle angosce quotidiane, per non fare del male, per sentirsi ancora parte integrante delle nostre sensazioni e stati d’animo.
Le lacrime di sudore sulla fronte, i vestiti bagnati, lo spazio ristretto, tutto questo aiuta a far andare le mani e per un attimo a fermare la mente. Capita che non si abbia voglia di vedere nessuno, di sorridere fintamente e stringersi in una solidarietà un po’ annacquata. Allora, in quei giorni, è meglio rifugiarsi lì dietro dove nessuno vede e ci si può commuovere l’anima, lo spazio e la vita.
Ci sono certi momenti che passano senza fermarsi mai e vengono tutti vissuti alla Mensa, uno dopo l’altro. Si porta dentro il proprio vivere, la fragilità. Perché nessuno ha la chiave per rispondere alle domande del tempo, per raccogliersi nel sorriso del mondo, troppo grande e complicato. Anche se c’è chi crede a questo in modo quasi provocatorio, come se fosse la superiorità il desiderio mancato per scrivere i giorni, per riconciliarsi con le nostre prospettive di senso e di significato. Qui alla Mensa del povero, la strada per la vita.
Esci dalla mensa/ con la borsa sotto al braccio/ cappotto, ragazzo vestito di vento.
Scrivo, scrivo sempre versi che rimandano all’essenza anche difficile del vivere la povertà, la marginalità, a quello che non siamo, che non possiamo più diventare, senza voce.
“Non importa se c’è qualcuno arrabbiato con te” mi dice Jimmy un pomeriggio mentre siamo seduti insieme sul muro che delimita la serranda abbassata di una lavanderia in via Giuseppina Strepponi. Si aspetta l’orario di apertura e intanto per proteggersi dal caldo, ricerchiamo un po’ d’ombra e la parola “loro spesso non sanno quello che vogliono – continua – e dicono, dicono, ma tutti devono seguire le stesse regole, altrimenti non c’è rispetto”. Poi si guarda un po’ intorno, i capelli grigi, lunghi, cadono quasi sulle spalle e gli occhi azzurri brillano con il sole d’estate. La pelle viva negli anni e i denti che non ci sono più si aprono in un sorriso e in un’espressione un po’ stupita “Ah, Lodi non è più bella come una volta, gherano i campi, al posto di tutte queste strade e l’Isola Carolina era diversa: i giochi, il trenino, gli animali, non tute qele robe chi de ades”.
Lo sa Jimmy che i tempi cambiano, ma bisogna tenersi strettamente legati a quello che siamo, anche al nostro essere in bilico, sul filo del tempo. Come Giacomo Leopardi che si commuove a osservare l’eruzione del Vesuvio e scrive, scrive parole profonde, che tratteggiano gli attimi trasfigurati di vita di ognuno di noi.
Questi campi cosparsi
di ceneri infeconde, e ricoperti
dell’impietrata lava,
che sotto i passi al peregrin risona.
Le parole del poeta, che attraversano secoli, sono un po’ come quelle di Jimmy: il simbolo di una mente ingombrante, di un tempo che sta ritornando e di una felicità che bussa sempre quando non siamo in casa, che ci fa trovare impreparati. Non ci sono altri segreti, altre vie per il giorno, altri vestiti da stirare per il mattino dopo. Lui è così come quando una sera entra in Mensa, prende il vassoio come sempre protestando e bestemmia in faccia a un prete che era venuto ad aiutarci. Questo con il frutto in mano dice “Mi scusi, un po’ di rispetto, io mi sono offeso”. Lui, si è offeso e il nostro tempo è quello dell’ultimo abbraccio, della relazione che non c’è più, della condivisione che ha perso ogni attimo di essenzialità e coraggio, di profondità.
Ci fa capire che siamo troppo indifesi per ascoltare la vita, per ricordarci nella sua interezza, per apprezzarne anche le consuetudini.
“La vita va, passa, ma io sono sempre qui fermo” dice Mohammed, giovane libico, nato da genitori gambiani, per cui nero di pelle. Lo sguardo perso nel nulla del non ritorno, la voce tenera di chi si guarda intorno e ricerca la strada per vivere. Ancora “per me è importante la religione, la preghiera, l’umiltà. Sono musulmano ma sono andato tante volte nelle Chiese Cattoliche e in quelle pentecostali dove spesso si ritrovano i Nigeriani. Voglio dire che ci sono tante strade per arrivare a Dio, ognuno sceglie il modo che preferisce, la Sunnah che vuole percorrere”. Per Mohammed è importante questo, per avere ancora la forza di continuare a sperare. In Libia chissà quante cose avranno visto i suoi occhi, quello di cui parlano spesso i segni sulla pelle di molti, che sono il loro prezzo da pagare per cercare pace che fanno poi fatica a conquistare. Chissà come deve essere difficile tenere tutto dentro. Ma non glielo chiedo, troppo complesso aprire i cassetti dei ricordi, in cui si accumula la polvere che rischia di scoppiare. Non ne ho il coraggio, ancora. E’ come con Jimmy, è meglio lasciare perdere certe volte, insegna. Così come quando mostra il suo orologio digitale a Mario “questo lo voglio vendere a venti euro, se me li dai è tuo”.
Poi tira su da terra un mozzicone e lo mette in bocca, aspirando con gioia, come se fosse una sigaretta infilata in un pacchetto appena comprato. Non siamo nient’altro. Non c’è bisogno di nient’altro, di domande superflue, che cancellerebbero la semplicità di cui ci circondiamo. Così come quando passo davanti all’Ospedale, di notte, per tornare a casa e vedo Beppe e Ivan seduti sulla panchina all’entrata. Con la testa bassa, protetti dalla luce della luna. A parlare di passato e di gioventù, o chissà di cosa. Non li interrompo, ma li guardo, mentre continuo ultimo viandante sulla strada del cielo a ripercorrere la spiritualità della cassa della mia anima. Basta solo quello e il cuore che cede all’amore.
Ascolta l’episodio anche su Spotify
Comments
Condividi: