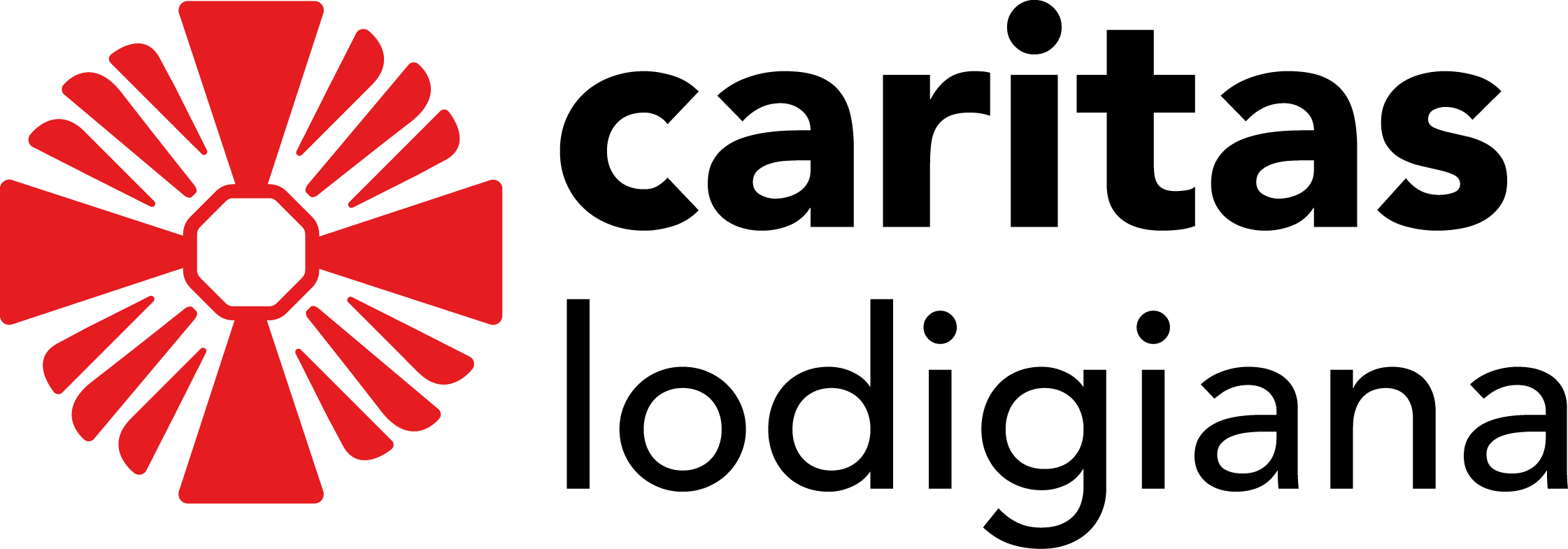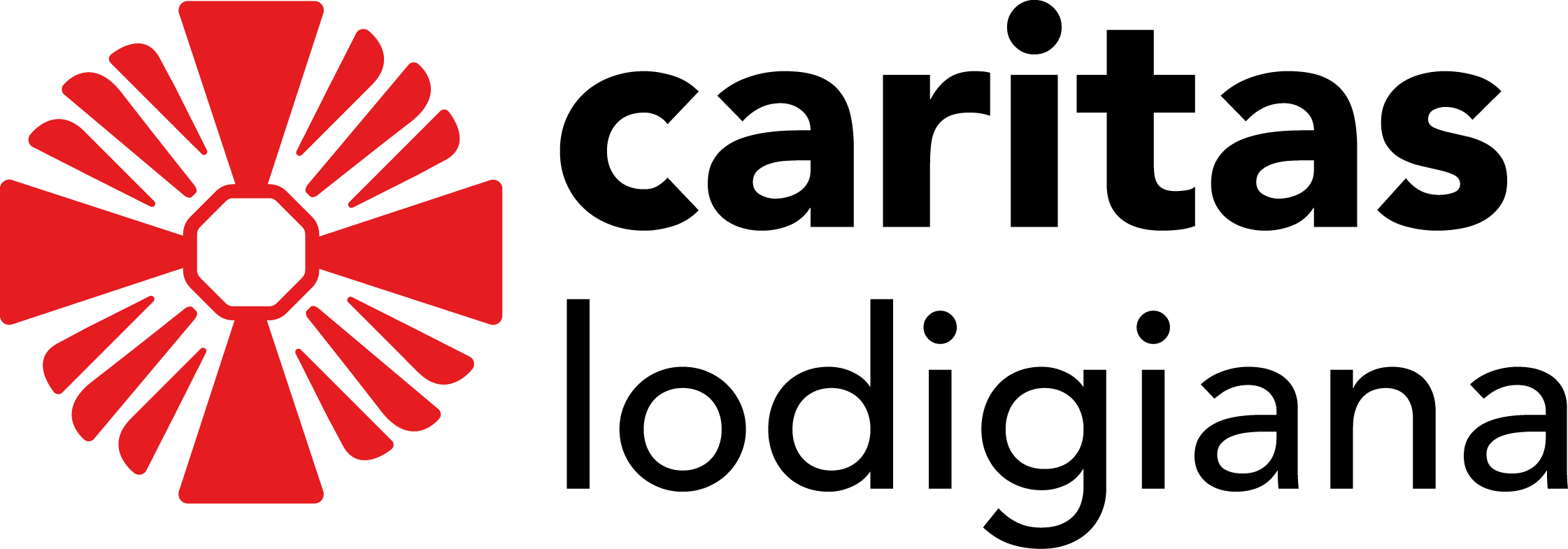Capitolo 2: Silenzio di vita
- 11 Settembre 2023

È tempo di un caldo giovedì di luglio, Giselle è appena tornata dalle vacanze in Belgio, dove è stata a trovare sua sorella. Giselle viene dal Camerun e lavora alla Caritas, alla casa femminile San Giacomo e in Mensa dove si occupa di gestire il servizio, registrando le presenze e intervenendo in caso di bisogno. Non è molto alta e ha dei bellissimi capelli che cambia in base ai suoi desideri e necessità. Ama le regole e soprattutto che vengano fatte rispettare. Ha un carattere forte, che unisce alla spensieratezza e alla parola che per fortuna non le manca mai, coltiva nella sua profondità il mistero da svelare giorno dopo giorno e la voglia di credere nel tempo e nel destino. Sa tenere testa agli ospiti quando la fanno arrabbiare o quando non condividono una decisione che è stata presa.
“Si tratta di rispetto – mi dice – di imparare a essere responsabili, bisogna insegnare alle persone come crescere, quale strada raccogliere, che via seguire, ma non lo possiamo fare se trattiamo sempre tutti come poverini, per questo io sono così severa per quanto riguarda la tutela delle regole”.
Quando finiamo il servizio spesso percorriamo la stessa strada per tornare a casa e parliamo, parliamo del tempo, della vita, del coraggio di cui abbiamo bisogno per costruire il futuro, per credere nel domani, per andare oltre il dolore, la sofferenza, l’impossibilità, perché la speranza salvifica sia la strada più viva e vera di significato, più colma di gioia e di misericordia.
“Torna questa sera che devo darti una cosa” mi dice mentre prepariamo i piatti e mettiamo le brocche di plastica sugli otto tavoli presenti nell’open space per iniziare a distribuire il cibo. Solitamente gli ospiti arrivano uno dopo l’altro, lasciano la loro tessera a Giselle e corrono a prendere il vassoio, un po’ di pane, un frutto, poi si passa al primo e secondo con contorno. Infine si siedono per consumare il loro pasto e per parlare con gli amici che hanno di fronte. Ci sono dei posti prestabiliti che tali devono sempre restare.
Tsing, l’indiano, nell’ultimo tavolo in fondo alla sala, seduto sulla sedia appoggiata al muro. È alto, di professione mungitore, nel suo paese, l’ha fatto anche qui qualche volta ma poco e adesso consumato dal vizio, si perde in pochi sorrisi e parole, raccolto in una serietà che spaventa qualcuno.
“Anni fa spaccava i vassoi perché non gli davamo qualche pezzo di pane in più – racconta Carola, una volontaria del venerdì a pranzo, – ora si è calmato, forse lo abbiamo un po’ educato su questo versante”.
È alto, prima con una lunga barba e folti capelli raccolti nell’immancabile turbante rosso, poi ha dovuto cambiare pettinatura perché altrimenti non gli avrebbero rinnovato i documenti. È venuto un giorno alle docce e ha chiesto rasoio e schiuma da barba, poi quando è uscito non sembrava più lui. Ancora, Jimmy e Omar, rigorosamente sempre con le sue stampelle, compagne di viaggio e di un sogno che dall’Egitto lo ha portato a Lodi, nella follia del desiderio, vicini nel primo tavolo dando le spalle al buffet. Poi gli altri un po’ dove capita, gli africani seduti con gli africani, parlano, scherzano, a seconda dell’umore, si raccolgono nel tempo e nel mangiare un cibo così diverso dal loro al quale ormai si sono abituati.
Questo giovedì mattina però non è come gli altri. La mensa è ancora chiusa, stiamo ultimando i preparativi per il pranzo. Un ragazzo somalo si attacca al campanello e inizia a suonare ripetutamente, nonostante Giselle supplichi di fermarsi. Dopo alcuni avvertimenti, si precipita alla porta e la apre, sperando di calmare quel tedio insopportabile. Invece il ragazzo inizia a urlare “Chi cazzo credi di essere? Pensi che questa sia casa tua e tu possa fare quello che vuoi?”. Giselle tenta di controbattere ma questa volta non basta neanche il suo atteggiamento responsabile e forte, la follia è grande, così si sbatte la porta dietro alle spalle. Lui allora inizia a buttarsi sul portone di vetro, a picchiare i pugni come un pazzo, finché la sua cornice di plastica dura e gomma si stacca completamente cadendo a terra con un rumore che taglia la stanza e per un attimo il silenzio. Forse un sogno o un grido ma sembra che Giselle agli occhi abbia qualche lacrima di commozione
“Io non ce la faccio più – grida ansimando – non è possibile lavorare così, adesso chiamo la polizia e non apro finché non arriva”.
Intanto il ragazzo tenta di andare via, ma la polizia arriva e anche Pito, che lavora al Centro di Ascolto e tenta di mediare con i poliziotti e con il giovane. Così il portone si apre e cinquanta persone si riversano nella sala, degli otto tavoli sono tutti occupati e c’è chi deve aspettare in piedi, intanto i vassoi sporchi si accumulano e chiedo l’aiuto a qualche ospite “Forza Kennet mi dai per favore una mano? Passami i vassoi che iniziamo a lavarli”.
Così ci si fa forza mentre l’istinto di follia della vita che non perdona, anche oggi ci insegna quanto siamo fragili, anche oggi ci dice che l’uomo ritrova in se stesso e negli altri il proprio dolore, che ognuno di noi ha la sua croce da portare sulle spalle e soffre, senza più niente da dire. Il ragazzo aveva già manifestato questi atteggiamenti rompendo un piatto nei giorni scorsi perché pensava che noi gli dessimo da mangiare carne di maiale. Cosa impossibile visto che la Caritas sa benissimo che ha a che fare soprattutto con musulmani.
“Tutti abbiamo dei problemi – mi dice Giselle mentre prepariamo insieme la macedonia – ma nessuno è legittimato a comportarsi in questo modo. Sono arrabbiata perché ci sono diversi luoghi dove si possono affrontare determinate problematiche, anche mentali, ma la mensa non è uno di quelli”.
Ancora “Ho pianto tanto per ragazzi come Ibra che a un certo punto della loro vita in strada hanno perso la testa, il senno, la ragione, si sono dimenticati della loro storia, ci hanno minacciati in preda alla follia. Non sapevo come fare, come cambiare le cose, come sperare che il domani di luce potesse continuare a sorgere di un sole più vero”. Anche io allora avevo pianto tanto, così come oggi ad assistere a quella scena. I volontari un po’ spaventati, si sono raccolti nel cucinotto attendendo che tutto si tranquillizzasse. Io come Giselle ho pianto. Lacrime di parole, dagli occhi d’inchiostro, dal tempo di credere nel potere salvifico del verbo, come regola dell’esistere, come bocca che narra la vita e che consente all’uomo di riconciliarsi con se stesso.
La poesia serve a questo: a raccontare quello che non tutti riescono a vedere, a vibrare con l’Universo, con la spiritualità, a crescere nel silenzio e nella meditazione, a ricordarsi che si nasce e si muore sempre, come ciclo naturale del ricordo, come pezzi di vetro caduti dal letto d’incenso.
Parola, tempio della speranza, racconto senza fine.
Non abbiamo più niente e vorrei che tornassi a casa
sulla strada degli alberi secchi
il freddo nel tempo del pane,
la voce di Africa calda d’amore
E cerchi alla Mensa degli occhi vuoti di fiato
il destino che non so trovare
la chiave di sabbia e profumo
Vestiti strappati
segnali di rabbia e follia
che getti nel fondo del pozzo la stella più vera
che scrivi nel pianto e raccogli paura
Non abbiamo abbastanza parole
sulla strada triste della sera.
Parole raccolte una dopo l’altra, che hanno disegnato anche con l’incertezza un modo per sentirsi parte, per non dimenticare, per credere che esista sempre qualcosa in più e che non dobbiamo mai accontentarci della morale della ragione strumentale, soggettiva che riduce la mente a un mezzo per raggiungere determinati fini. Non dobbiamo credere all’incantesimo di Dewey, che secondo il modello americano, ha convinto l’uomo che un’oncia di esperienza valga di più che una tonnellata di contenuto. Dobbiamo salvare l’anima e la mente da tutti coloro che fingono di essere padroni, i potenti, i forti, quelli che hanno diviso il mondo secondo le classifiche del giudizio. L’uomo resta uomo sempre, con la porta del cuore aperta. Decidere adesso che ci basta commuoverci e sperare, continuare a credere che esista un solo e unico padrone degli uomini: Dio.
Così si impara alla mensa dove la Croce appesa sulla parete non esclude la possibilità che ci si saluti in arabo, che si invochi Allah, che si speri in Dio come possibilità salvifica dell’esserci, così come alhamdulillah. O come lo stesso Kabu che ogni volta prima di entrare dalla porta sussurra Bismillah. Macumba Diack è un operatore Caritas che alterna ai turni in mensa quelli notturni di controllo al dormitorio di Casa San Giuseppe. Una persona di poche parole, composta, educata, umile, che guarda agli altri con la determinazione di dover trovare sempre qualcosa di bello.
Come quel fanciullino di Pascoli che si agita e detta nella mente di un poeta, quel sogno segreto che dovremmo conservare sempre, anche quando gli anni peseranno. Quello di osservare la vita con il coraggio della scoperta, dell’eterna domanda, senza avere per forza una risposta. Eccolo il fanciullino di Giovanni Pascoli, quello che ci fa riscoprire piccoli e indifesi di fronte alla morte di un padre, o che rimanda alla sicurezza del suono di una culla durante un temporale. Anche questo vuol dire avere Fede: non fare affidamento solo ed esclusivamente sulla certezza, ma compiere quel salto al di là della ragione, è la legge del cuore, quella che ci permette di pensare che non sia tutto concreto, tutto razionale, che il nostro sentire abbia bisogno necessariamente di qualcos’altro.
Il tempo e la vita, la musica dell’essere parte senza fine di quel panta rei eracliteo, come circuito continuo ed eterno, come viaggio delle cose nel mondo, della cosalità che trascende anche i limiti fisici della realtà gnoseologica.
È la rappresentazione fisica della nostra coscienza disgregata di uomini. Qualche volta il sogno salva, come con Miguel de Cervantes e il suo Don Chisciotte: andare contro i mulini a vento vuol dire avere il coraggio di credere nel sogno, oltre un mondo che si accontenta dell’ingiustizia, del male, della sete di potere, vuol dire avere la determinazione di andare al di là delle accuse, dei falsi moralismi e perbenismi intravisti dalla becera ottusità.
È infatti proprio quando Don Chisciotte rinsavisce che arriva il momento della morte, la fine di un viaggio, di un sogno, di una nuova possibilità. Macumba Diack, Cheick come si fa chiamare lui, arriva dal Senegal, è alto e ha profondi occhi neri che sembra di caderci dentro, sprofondare nell’abisso della cenere senza lasciare traccia. Il suo stile è camicia di flanella, cappello e una sciarpa di lana, qualsiasi stagione ci sia, qualsiasi temperatura. Non bisogna perdere la propria dimensione, il proprio stare bene e Kabu me lo ricorda sempre. Così come quando scambia qualche parola in wolof con alcuni ospiti della mensa suoi connazionali, o condividiamo lo stesso tratto di strada. Non si spreca in quello che non si può dire, non si affaccia su quello che è troppo e che non possiamo descrivere, ma ha la determinazione di poter decidere da che parte stare, di essere in un certo senso partigiano del coraggio e del nostro sentire. Poi sorride e il sorriso nascosto risuona nel cielo d’autunno, come una prospettiva pura, senza fine. È all’interno di pochi metri quadrati che si snodano le mie giornate. Alternati a dei momenti di pausa, ma ogni volta che percorro le strade di Lodi, li vedo, li saluto, mi siedo con loro, mi fermo a scambiare qualche parola per cercare di capire, di crescere, di divenire sempre più grande, nell’incertezza di quello che ancora non siamo e che facciamo fatica a concepire.
Non deve esserci una separazione, nella vita di una persona, tra quello che uno è e il suo essere volontario. Non può essere come una giacca da esibire nel momento del bisogno, come se ci si dovesse vantare di fare determinate cose, di seguire determinate strade. Ognuno la propria, con la bisaccia e la via dei sandali vuoti. Ma non si può pensare, una volta finito il turno, di dimenticarsi di quello che si è fatto, di tornare a casa pensando solo ed esclusivamente al proprio esistere. È quello che invece ci insegna il Vangelo: ci sono io e gli altri. Io nell’altro come metafora concreta delle storie che si devono raccontare, per necessità di spirito, acutezza di sguardo, profondità di sapere. Il nostro è il filo rosso da seguire, la speranza per il futuro.
Ci sono momenti positivi e negativi, anche. Tutto si vive alla mensa del pane spezzato, come se fosse una seconda casa, la vita che è fatta di gioie e dolori, speranze e impossibilità. Allora condividerle con gli altri, ricercare nello sguardo, nell’abbraccio, nella stretta di mano, una strada diventa una grande consolazione. Essere chiamati bastardi è capitato, essere stati mandati a quel paese solo per aver negato di portare fuori del cibo, o aver consigliato di comportarsi in una certa maniera. È comunque un luogo di fragilità, di incertezza, in cui ogni parola va pesata, ogni comportamento, modo di fare, di agire può influire su come si comporteranno gli altri ospiti, su cosa diranno, su come si verrà trattati. Perché le persone esigono rispetto e certe volte si dimenticano di darlo, nonostante lo ricevano, perché anche chi è in una situazione di povertà fa fatica ad accontentarsi e con certi atteggiamenti infantili ferisce. Siamo anime alla ricerca della notte, appesi su questo filo della sera, tra il tramonto della luna, alla foce del fiume, dove si stendono storie e si raccontano le ultime fiabe prima di dormire.
Lì a Casa Bianco, come la chiama Diamanka. La sua casa è quella: il ponte della tangenziale che si appoggia sulle rive dell’Adda. “Come mai non ti ho visto oggi alla mensa? Tutto bene? – gli mando un sms, lui mi risponde – sì sì tutto bene oggi ho mangiato a Casa Bianco”. Ecco perché non è venuto, bisogna pulire, sistemare, anche mangiare così come si fa in una casa. Una sera camminando tra i campi di grano per raggiungere la zona dei laghi – è una passeggiata insolita di Lodi che ricongiunge con la natura – sento qualcuno che mi chiama, è Diamanka: con un cappellino verde e la voce senegalese che sorride nel vedermi.
“Vuoi venire a vedere Casa Bianco?”.
Magari un’altra sera…
Lui che ogni volta che entra alla mensa grida “Dai che non c’è tempo, forza”. Chissà che cosa c’è sempre di così importante da fare, bisogna andare di fretta, ci sono ovviamente altri sogni, altre speranze, altre necessità. Il ponte è dove all’addiaccio, si consumano le vite, si trasfigura una felicità diversa, insolita, persa alle stazioni dei treni mai presi, ricostruita come un racconto senza fine. Non sarebbe d’accordo Jimmy la cui frase preferita è “Con la calma si fa tutto”.
Capita che qualche volta seduto al tavolo tiri fuori la sua fisarmonica e inizi a suonare, sempre la stessa melodia, come se per lui però fosse diversa, ogni volta speciale, ogni volta un gesto d’affetto.
Si trascina con la vecchiaia e i segni della povertà sul volto e dei denti che non ci sono più, dei suoi capelli grigi un po’ ingialliti per via dei toscanini fumati e dei mozziconi raccolti dalla strada, messi in bocca e aspirati con il sorriso sulle labbra di vetro.
“Lasciamo perdere se no ndem più a ca” il suo dialetto lodigiano e i suoi commenti poco felici sugli africani che siedono vicino a lui e che spesso si divertono a prenderlo un po’ in giro, lo rendono un abituè della mensa, uno che con la sua mania di accumulare si è ritrovato in un mondo strano, diverso, nuovo, in cui si ha ancora il coraggio di una carezza di parola e di una ricerca fine e concreta.
Si raccontano in queste pagine uno dopo l’altro, quando si guardano e si ritrovano nell’emozione della poesia, nel sogno di un nuovo modo di essere e di scrivere parole. Certi giorni più difficili, altri meno. Ma come insegna Mario che viene da Agrigento e dice di essere stato un famoso musicista in passato “Certe cose, certi cambiamenti anche radicali servono per dare una svolta a un po’ di appiattimento che si può creare con il passare dei giorni, insegnano a vivere e a condividere”. Così con queste poche parole scambiate seduti alla panchina della fermata della corriera, per attendere l’orario di inizio del servizio, Mario si racconta e vive nei tempi della musica e delle sinfonie dei giorni, del consumo della nostra età post moderna e del nostro continuo vuoto sociale e morale. I costumi, la certezza dell’essere, tutto è cambiato e l’inconsistenza è un carattere tipico dei tempi che ci avvolgono.
Bisogna seguire la nostra strada, con la certezza di potere fare qualcosa di significativo, anche controcorrente, anche in direzione ‘ostinata e contraria’ al totalitarismo liberista e capitalista della civiltà occidentale che induce l’uomo a ritrovare felicità e la propria identità solo ed esclusivamente nel consumo.
Altro che pensiero, avrebbe scritto Zygmunt Bauman, in Consumo dunque sono non c’è più quel Cogito ergo sum cartesiano, l’identità della persona si forma nel momento in cui persegue quel determinato bene. Così oscilla tra il dolore e la noia. Il dolore quando non riesce ad ottenerlo, la noia invece quando lo raggiunge e non sa più dove guardare, cosa cercare, dove incontrare il suo sguardo in quello degli altri. È la società liquida che, contrapposta a quella solida, non dà all’uomo una possibilità salvifica di ricerca ultima, non permette più di avere valori, legami, necessità esistenziali che vadano oltre il consumo. Oltre la via dell’indifferenza, della perdizione, dell’impossibilità.
Percorriamo tratti di strada che non si possono raggiungere, corriamo scalzi sulla sabbia senza più niente da dire e il vestito del vento sulla pelle, di giorni e ricordi, su quello che siamo.
E’ il nostro tempo, il condividere, il ricercarci parte integrante del mondo, con le sue difficoltà, non necessità, nella possibilità di essere veri e vivi, vicini agli altri, al nostro sentire. Scrive Friedrich Nietzsche
“La condivisione di una gioia fa di un uomo un vero amico. Condividere le gioie e le speranze, i dolori e le impossibilità, anche i giorni più difficili”.
Questo è il tempo della Mensa: quello dell’incertezza, di quando non si ha più coraggio di continuare il cammino e di seguire quella speranza che ci perseguita da sempre: essere felici.
Ascolta l’episodio anche su Spotify
Comments
Condividi: